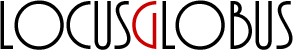- Home
- Storia Economia Società
- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto
- Archeologia
- Venetkens | Veneti antichi
- Civiltà romana
- Le origini di Venezia
- Il Veneto nel Medioevo
- La Repubblica veneziana
- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli
- La fine della Repubblica veneziana
- Veneto e Risorgimento
- La cessione del Veneto all'Italia
- Il Veneto dopo l'Unità
- Emigrazione
- Ebraismo nel Veneto
- Grande Guerra
- Fascismo e Resistenza
- Società veneta contemporanea
- Accadde oggi
- Cultura
- Personaggi
- Personaggi in primo piano
- Agostinetti Giacomo (Jacopo)
- Albrizzi Almorò
- Aleandro Girolamo
- Aleandro Girolamo il Giovane
- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)
- Amalteo Francesco
- Amalteo Pomponio
- Angeli Antonio
- Belli Bortolo
- Benvenuti Arturo
- Beretti Valentico Adriano
- Bernardi Mario
- Bernardi Ulderico
- Bevilacqua Giuseppe
- Borsato Gino
- Bottero Antonio
- Brusatin Angelo
- Bucciol Eugenio
- Buso Armando
- Cadamuro Olga Olimpia
- Caligiuri Clelia
- Capitone Gaio Voltejo
- Caramel Angelo "Elo"
- Caramel Giacomo
- Carrer Giovanni Battista
- Casoni Francesco Opitergino
- Casoni Guido
- Cecchetti Raimondo
- Chinazzo Daniele
- Cibin Luigi Pompeo
- Ciganotto Lodovico
- Colao Lucia
- Colombo Michele
- Costariol Dino
- Cristofoletti Ciro ed Eugenio
- Dal Pozzo Pietro
- Dall'Ongaro Francesco
- Dall'Oste Luigi
- Dall'Oste Pietro
- Dal Sasso Severino
- Daniotti Sanfiore Francesco
- Darzino (Caramel) Bruno
- De Domini Giampietro
- Donadon Tiburzio
- Erler Giulio Ettore
- Erler Tino
- Floriano di Oderzo
- Furlan Antonio
- Gardin Antonio
- Gini Corrado
- Girardini Giovanni
- Kuzminac Goran
- Lippi Giuseppe
- Lozer Giuseppe
- Luchesi Andrea
- Lunardelli Geremia
- Luzzatti Luigi
- Magno di Oderzo
- Mantovani Gaetano
- Manzoni Domenico
- Martini Alberto
- Melchiori Francesco
- Mengaldo Angelo
- Molmenti Pompeo Marino
- Montemezzo Antonio
- Moretti Giuseppe decano di Oderzo
- Nardi Carlo
- Padovan Carlo Simeone
- Palatini Leopoldo
- Paludetto Franz
- Prosdocimo Giorgio Domenico
- Querini Benzon Marina
- Rocco Lepido
- Rolleri Bevilacqua Angelita
- Roma Gina
- Sabbionato Bartolomeo
- Scarpa Antonio
- Serato Massimo
- Soletti Pietro
- Tagliapietra Pilade
- Talier Angelo Natale
- Tiziano di Oderzo
- Tomitano Giulio Bernardino
- Tomitano Pompeo
- Vietri Tullio
- Vizzotto Alberti Enrico
- Vizzotto Alberti Giuseppe
- Zanardo Aldo
- Personaggio dell'anno
- Trevigiani illustri
- Ricerche in corso
- Personaggi in primo piano
- Tra Piave e Livenza
- Territorio Ambiente Paesaggio
Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza
- Home
- Storia Economia Società
- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto
- Archeologia
- Venetkens | Veneti antichi
- Civiltà romana
- Le origini di Venezia
- Il Veneto nel Medioevo
- La Repubblica veneziana
- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli
- La fine della Repubblica veneziana
- Veneto e Risorgimento
- La cessione del Veneto all'Italia
- Il Veneto dopo l'Unità
- Emigrazione
- Ebraismo nel Veneto
- Grande Guerra
- Fascismo e Resistenza
- Società veneta contemporanea
- Accadde oggi
- Cultura
- Personaggi
- Personaggi in primo piano
- Agostinetti Giacomo (Jacopo)
- Albrizzi Almorò
- Aleandro Girolamo
- Aleandro Girolamo il Giovane
- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)
- Amalteo Francesco
- Amalteo Pomponio
- Angeli Antonio
- Belli Bortolo
- Benvenuti Arturo
- Beretti Valentico Adriano
- Bernardi Mario
- Bernardi Ulderico
- Bevilacqua Giuseppe
- Borsato Gino
- Bottero Antonio
- Brusatin Angelo
- Bucciol Eugenio
- Buso Armando
- Cadamuro Olga Olimpia
- Caligiuri Clelia
- Capitone Gaio Voltejo
- Caramel Angelo "Elo"
- Caramel Giacomo
- Carrer Giovanni Battista
- Casoni Francesco Opitergino
- Casoni Guido
- Cecchetti Raimondo
- Chinazzo Daniele
- Cibin Luigi Pompeo
- Ciganotto Lodovico
- Colao Lucia
- Colombo Michele
- Costariol Dino
- Cristofoletti Ciro ed Eugenio
- Dal Pozzo Pietro
- Dall'Ongaro Francesco
- Dall'Oste Luigi
- Dall'Oste Pietro
- Dal Sasso Severino
- Daniotti Sanfiore Francesco
- Darzino (Caramel) Bruno
- De Domini Giampietro
- Donadon Tiburzio
- Erler Giulio Ettore
- Erler Tino
- Floriano di Oderzo
- Furlan Antonio
- Gardin Antonio
- Gini Corrado
- Girardini Giovanni
- Kuzminac Goran
- Lippi Giuseppe
- Lozer Giuseppe
- Luchesi Andrea
- Lunardelli Geremia
- Luzzatti Luigi
- Magno di Oderzo
- Mantovani Gaetano
- Manzoni Domenico
- Martini Alberto
- Melchiori Francesco
- Mengaldo Angelo
- Molmenti Pompeo Marino
- Montemezzo Antonio
- Moretti Giuseppe decano di Oderzo
- Nardi Carlo
- Padovan Carlo Simeone
- Palatini Leopoldo
- Paludetto Franz
- Prosdocimo Giorgio Domenico
- Querini Benzon Marina
- Rocco Lepido
- Rolleri Bevilacqua Angelita
- Roma Gina
- Sabbionato Bartolomeo
- Scarpa Antonio
- Serato Massimo
- Soletti Pietro
- Tagliapietra Pilade
- Talier Angelo Natale
- Tiziano di Oderzo
- Tomitano Giulio Bernardino
- Tomitano Pompeo
- Vietri Tullio
- Vizzotto Alberti Enrico
- Vizzotto Alberti Giuseppe
- Zanardo Aldo
- Personaggio dell'anno
- Trevigiani illustri
- Ricerche in corso
- Personaggi in primo piano
- Tra Piave e Livenza
- Territorio Ambiente Paesaggio
- Sei qui:
-
Home

-
Tra Piave e Livenza

-
Paesi del Piave

- San Polo di Piave
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: San Polo di Piave
- Visite: 3169

- [VIDEO] San Polo di Piave, «Borghi d'Italia», 1/6/2018 | tv2000.it/borghiditalia
Cenni storici
Tradizionalmente si presume che primi nuclei abitati nel territorio sampolese siano sorti lungo la strada romana “Opitergium Tridentum” - anche se non se ne è mai identificato finora il sito esatto - che partendo da Oderzo avrebbe potuto portare verso le prime colline, passando per le attuali località di San Giorgio e Caminada e proseguendo per Tezze di Piave. Lo renderebbero verosimile i molti materiali di epoca romana, mattoni ed embrici, riaffiorati lungo questa direttrice.
Con la caduta e la distruzione di Oderzo ad opera dei longobardi nel 667, e la successiva divisione del territorio della diocesi opitergina fra i Vescovi di Treviso e Ceneda ed i duchi friulani, il Patriarca di Aquileia rivendicò il diritto di possesso su quattro pievi poste lungo il tragitto per recarsi alla reggia longobarda di Pavia. A quell’epoca risale il toponimo “San Polo del Patriarca”, località ritenuta strategica per assicurare il passo sul Piave e riprendere quindi la strada Postumia. La pieve cominciò da allora ad avere una vita amministrativa ed ecclesiastica staccata dal contesto dei territori limitrofi. Nel XIV secolo dopo continue guerre, venne meno il potere temporale del patriarca di Aquileia sul territorio di San Polo che, presumibilmente attorno al 1388, passò sotto il dominio veneziano.
Con l’investitura dell’11 marzo 1452, Venezia concede a Cristofaro da Tolentino i feudi di San Polo e di Aviano in seguito alla fedeltà dimostrata dai Tolentino, capitani di ventura a capo di un piccolo esercito prezzolato. Estintasi nella discendenza maschile dopo pochi anni, il Senato veneziano rinnovò nel 1506 l’investitura comitale alla famiglia Gabrieli che resse per tre secoli il feudo di San Polo, emanando proprie leggi e statuti, fino al 9 dicembre 1805, quando si estinse con l’ultimo Conte Angelo Maria Gabrieli, inquisitore di Stato della Serenissima Repubblica nel 1797, anno della caduta di Venezia.
L’antico feudo mantenne una certa integrità anche nei tempi più recenti, prima acquistato dai fratelli Vivante, ricchi banchieri veneziani di origine ebrea allo scopo di investire cospicui capitali in terraferma, poi dai Connati Papadopoli ed infine in questo ultimo secolo dai signori Giol.
Molte volte il fattore generale delle amministrazioni Papadopoli e Giol era anche Sindaco o Podestà del Comune, riunendo nella stessa persona la proprietà fondiaria e l’autorità civile.
La denominazione del comune fino al 1867 era San Polo.
Il 26 giugno 1971, la cessione delle terre ai mezzadri segnò la fine dell’antico feudo di San Polo che aveva mantenuto una sua precisa identità storica e geografica nel corso dei secoli fino ai nostri giorni.
Il Patriarca di Aquileia conservò tuttavia il diritto ecclesiastico sulla pieve di San Polo fino al 1751, quando, con la soppressione della sede patriarcale, la parrocchia passò all’arcidiocesi di Udine e dal 1818 al Vescovo di Ceneda. Con Regio Decreto del 10/11/1864 si arrivò all’attuale denominazione di “San Polo di Piave” che identifica oggi un territorio della grandi risorse agricole, viticoltura principalmente, con la produzione di ottime uve e vini, soprattutto i rossi Merlot, Cabernet ed il Raboso Piave. L’imprenditorialità mezzadrile delle generazioni precedenti ha contribuito allo sviluppo negli anni recenti di un gran numero di attività artigianali, commerciali e industriali in una realtà dalle notevoli potenzialità economiche.
Bibliografia | Sitografia
- Luigi Dall'Oste, San Polo nel Trevigiano. Cenni storici, aggiuntavi la genealogia dei Gabrieli, Tip. Antonelli, Venezia, 1874 | Leggi pdf
- Alberto Mioni, I Mioni e la terza parte dell'ex feudo di San Polo, Vittorio Veneto, 2011 | Reperibilità: debastiani.it
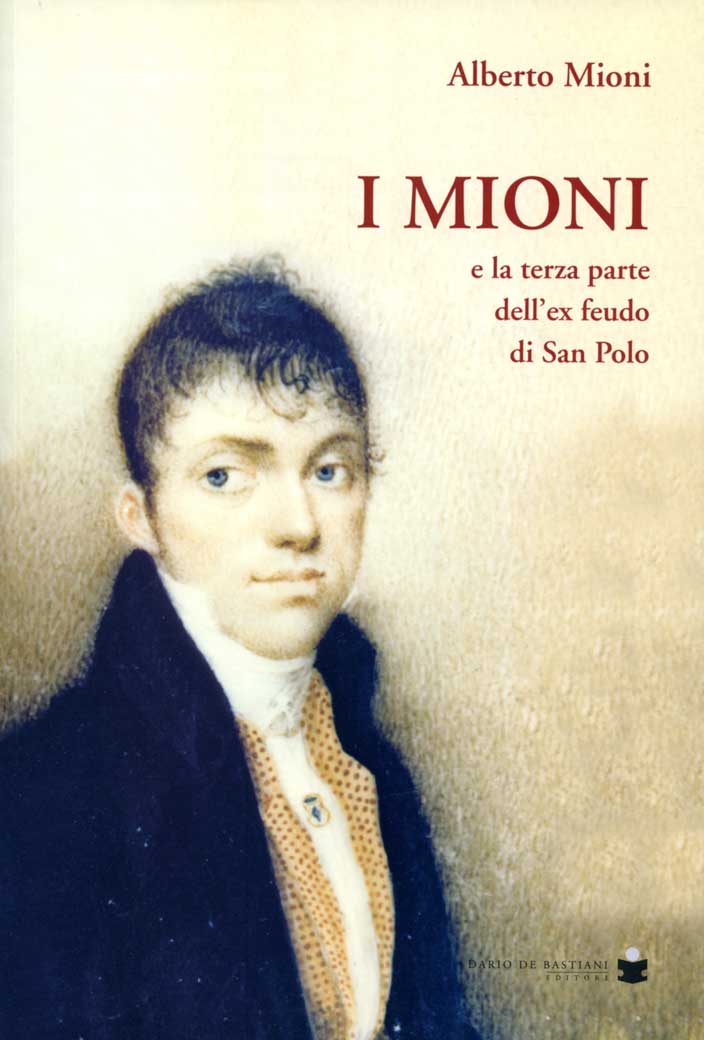
- Angiolini Nicla, Il Castello Papadopoli Giol ed il parco paesaggistico a San Polo di Piave. Storia, vicende e contesto, Tesi di laurea, UniVe, 2012-2013 | Leggi pdf | Secondo le fonti, fu Spiridione, uno dei sette figli del conte Angelo, a commissionare intorno al 1850, la costruzione del castello, nel sito in cui sorgeva la dimora dei Da Tolentino e dei conti Gabrieli, come testimonia Luigi Dall'Oste, amico di famiglia e frequentatore del castello.
- Castello Papadopoli Giol | castellogiol.it

Fonte: giornatavillevenete.it/castello-papadopoli-giol | villevenetetour.it/ville-venete/castello-di-papadopoli-giol | fondoambiente.it/luoghi/castello-papadopoli-giol
- Giovanni Tomasi, Gli autori degli affreschi di palazzo Gabrieli a San Polo di Piave, «Archivio Storico Cenedese», 5 / 2020, pp. 223-251 | Reperibilità: ascenedese.it/asc5

Palazzo Gabrieli | Fonte: davetto.altervista.org/foto/treviso/san_polo_di_piave

Palazzo Gabrieli 1918-1919 | Fonte: catalogo.beniculturali.it/.../0500346790
- Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo - San Polo di Piave | parrocchiadisanpolo.it/luoghi | La chiesa parrocchia
↓ In preparazione ...
Ex Filanda

Torre di Rai

Chiesa di San Giorgio

Il nucleo più antico dell’attuale chiesa di San Giorgio è stata edificato verso la metà del XV secolo sopra una struttura già preesistente; infatti anche questa chiesa è citata già nel 1034 su un Diploma imperiale tra i luoghi concessi in dominio al Patriarcato d’Aquileia.
Al suo interno è conservato uno stupendo ciclo di affreschi recentemente attribuiti a Giovanni di Francia (Metz 1420? – Conegliano ? 1473/85), pittore che nella prima parte della sua vita operò nel feltrino lasciando numerosissime testimonianze tra le quali un’Ultima Cena adoperando antecedentemente gli stessi cartoni di San Giorgio a Servo di Sovramonte. Nell’epoca della sua piena maturità artistica scese nel coneglianese operando a Zoppè di San Vendemmiano nella chiesa campestre di San Pietro in Vincoli non più esistente ma i cui affreschi sono stati staccati ed ora collocati e visibili presso il Museo del Castello di Conegliano.
Altre chiese che conservano affreschi di Giovanni di Francia sono San Vigilio a Col San Martino e la chiesa parrocchiale di Mareno di Piave. Del ciclo originario fanno parte in senso orario da sinistra per chi entra “La Madonna del Rosario con San Francesco”, l’Ultima Cena, la Storia di san Giorgio in quattro “Capituli” dei quali sono andati perduti i due centrali nell’ampliamento seicentesco per creare l’abside, i santi Sebastiano e Bernardino da Siena e i Santi Giacomo Maggiore e Antonio Abate.
Nella chiesa vi sono altri affreschi di epoche successive quali due Madonne col Bambino, una datata 1520 e l’altra databile alla fine del XV secolo, un San Rocco del XVI secolo e un San Martino del XVIII secolo. Vi era anche un affresco posto all’esterno della facciata principale raffigurante un’altra Madonna col Bambino di cui purtroppo non c’è più traccia. L’Ultima Cena è senza dubbio l’affresco più noto e caratterizzato dalla presenza sulla tavola del vino rosso e dei gamberi, prodotti tipici sampolesi anche all’epoca dell’affresco.
Il primo affresco della Storia di San Giorgio rappresenta il cavaliere che incontra la principessa figlia del re della città di Selene che si immola in riva al lago per placare il drago che minaccia la popolazione. Sotto l’affresco vi è una scritta nella lingua volgare del tempo che racconta l’episodio. Nell’ultimo quadro, San Giorgio dopo aver ammansito il drago e liberato la città di Selene, battezza gli abitanti rappresentati dal re, dalla regina e dalla principessa.
[La sintesi descrittiva è tratta da: parrocchiadisanpolo.it/luoghi/#sangiorgio]
- Roberto Lazzarin, Il culto di san Giorgio a San Polo di Piave, 11/6/2021 (sono riprodotti gli interni e gli affreschi che decorano le pareti) | mer-curio.com/.../il-culto-di-san-giorgio-a-san-polo-di-piave/
- La Chiesa di San Giorgio in San Polo di Piave. Gli affreschi, 20.5.2018 | vocidaiborghi.wordpress.com
- La Chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave ed i suoi affreschi | marcadoc.com
- Chiesa di San Giorgio, Ultima Cena | ultimacena.afom.it
- L'antica chiesa e località di San Giorgio in San Polo di Piave | chiesadisangiorgio.peruzzetto.org

Chiesa della Caminada

La doppia croce sulla sommità della facciata sta ad indicare il luogo di culto più antico della parrocchia di San Polo di Piave.
La chiesetta si vorrebbe edificata nel 1212 come adempimento della richiesta di erigere una cappella dedicata al culto mariano fatta dalla Madonna apparsa ad una giovane donna del luogo (Cfr. Don Firminio Concini, Il culto di Maria nella Diocesi di Ceneda, manoscritto in tre volumi, 1897, Biblioteca del Seminario di Vittorio Veneto). Le indagini archeologiche (del 1999), coincidenti con lavori di risanamento del perimetro esterno dell’edificio, fanno risalire al 1400 la datazione dell’attuale chiesa della Caminada, eretta su una precedente struttura con diverso orientamento.
Due secoli dopo, a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563), la chiesa fu ampliata su entrambi i lati, creando l’attuale abside dove un tempo c’era il portone d’ingresso, cambiando completamente l’orientamento da levante a ponente.
Per il pregevole affresco della “Madonna della Caminada”, recentemente attribuito alla scuola del Bellunello, fu usato lo stesso cartone a Tempio di Ormelle e ad Arzenutto di San Martino al Tagliamento, dove è conservato nella sua integrità.
Nel 1824 venne eretto il primo campanile poi abbattuto insieme alla chiesa nel corso dell’invasione austro ungarica del 1917-1918. Ricostruita nell’immediato primo dopoguerra, la chiesa subì un intervento radicale di restauro nel 1975 con l’abbattimento dell’abitazione del custode sacrestano e la realizzazione della nuova sagrestia.
Nel corso degli anni la chiesa ha beneficiato di svariati interventi promossi e finanziati dall’Associazione Caminada Sant’Anna, sorta nel 1993 per volontà di un gruppo di devoti: il risanamento esterno dell’edificio e del campanile, il restauro dell’antico crocefisso, la realizzazione dell’ambone, la collocazione di tre nuove campane per un concerto complessivo a sei note (ogni pomeriggio alle ore 17, i rintocchi delle sei campane suonano La Canzone del Piave in ricordo di tutti i soldati caduti in guerra), la ristrutturazione del tetto.
Il termine Caminada ha avuto molte interpretazioni: la più plausibile è stata ritrovata nei registri delle varie luminarie (Confraternite) dove le parole «far la caminada» significano andare in pellegrinaggio. Da secoli, infatti, la chiesa della Caminada è stata meta di pellegrinaggi che giungevano dalle località limitrofe, soprattutto per implorare la grazia della pioggia.
[La sintesi descrittiva è ricavata da: parrocchiadisanpolo.it/luoghi/#caminada]
Sottocategorie
© 2025 am+