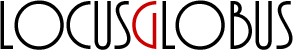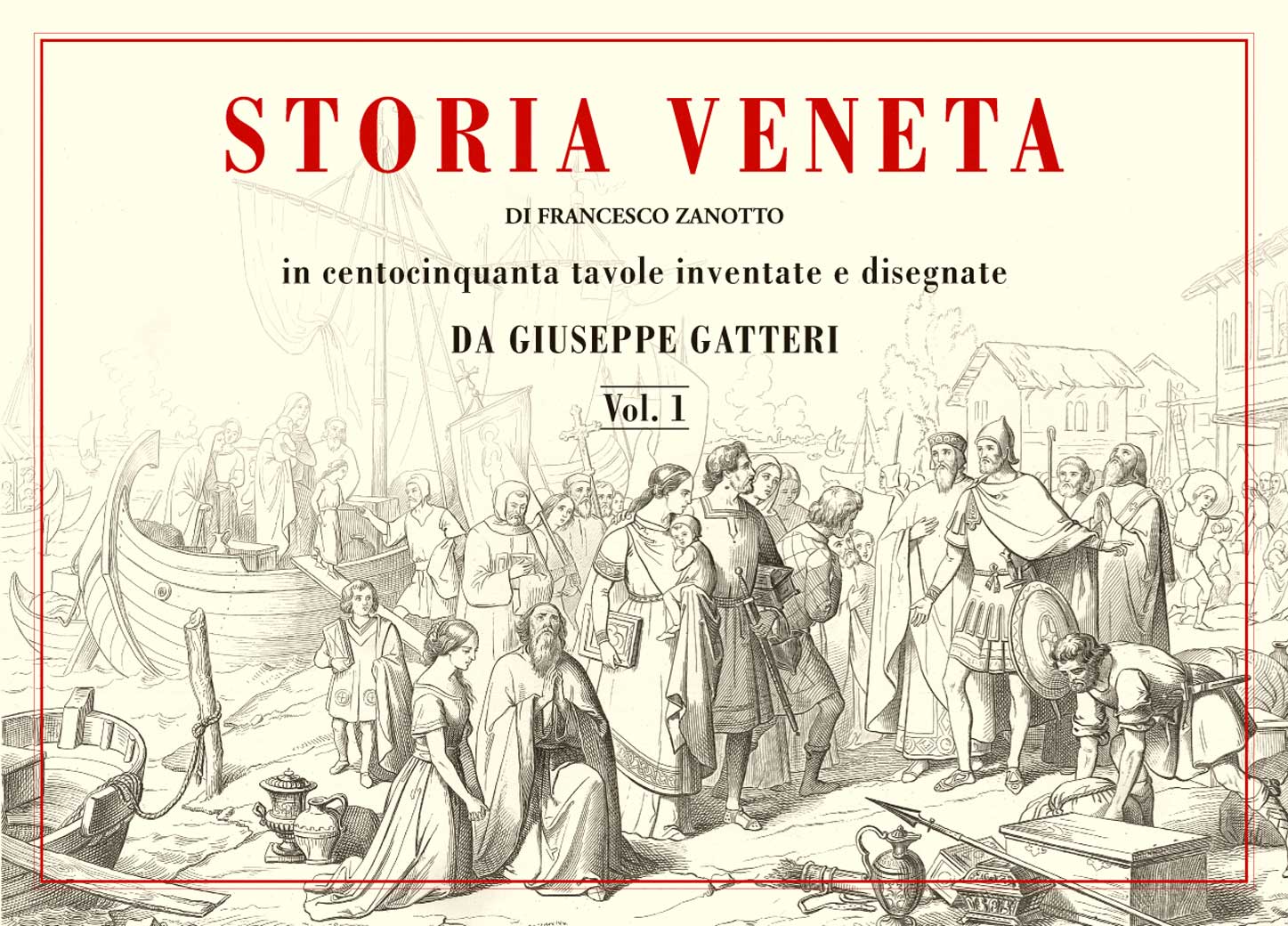- Home
- Storia Economia Società
- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto
- Archeologia
- Venetkens | Veneti antichi
- Civiltà romana
- Le origini di Venezia
- Il Veneto nel Medioevo
- La Repubblica veneziana
- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli
- La fine della Repubblica veneziana
- Veneto e Risorgimento
- La cessione del Veneto all'Italia
- Il Veneto dopo l'Unità
- Emigrazione
- Ebraismo nel Veneto
- Grande Guerra
- Fascismo e Resistenza
- Società veneta contemporanea
- Accadde oggi
- Cultura
- Personaggi
- Personaggi in primo piano
- Agostinetti Giacomo (Jacopo)
- Albrizzi Almorò
- Aleandro Girolamo
- Aleandro Girolamo il Giovane
- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)
- Amalteo Francesco
- Amalteo Pomponio
- Angeli Antonio
- Belli Bortolo
- Benvenuti Arturo
- Beretti Valentico Adriano
- Bernardi Mario
- Bernardi Ulderico
- Bevilacqua Giuseppe
- Borsato Gino
- Bottero Antonio
- Brusatin Angelo
- Bucciol Eugenio
- Buso Armando
- Cadamuro Olga Olimpia
- Caligiuri Clelia
- Capitone Gaio Voltejo
- Caramel Angelo "Elo"
- Caramel Giacomo
- Carrer Giovanni Battista
- Casoni Francesco Opitergino
- Casoni Guido
- Cecchetti Raimondo
- Chinazzo Daniele
- Cibin Luigi Pompeo
- Ciganotto Lodovico
- Colao Lucia
- Colombo Michele
- Costariol Dino
- Cristofoletti Ciro ed Eugenio
- Dal Pozzo Pietro
- Dall'Ongaro Francesco
- Dall'Oste Luigi
- Dall'Oste Pietro
- Dal Sasso Severino
- Daniotti Sanfiore Francesco
- Darzino (Caramel) Bruno
- De Domini Giampietro
- Donadon Tiburzio
- Erler Giulio Ettore
- Erler Tino
- Floriano di Oderzo
- Furlan Antonio
- Gardin Antonio
- Gini Corrado
- Girardini Giovanni
- Kuzminac Goran
- Lippi Giuseppe
- Lozer Giuseppe
- Luchesi Andrea
- Lunardelli Geremia
- Luzzatti Luigi
- Magno di Oderzo
- Mantovani Gaetano
- Manzoni Domenico
- Martini Alberto
- Melchiori Francesco
- Mengaldo Angelo
- Molmenti Pompeo Marino
- Montemezzo Antonio
- Moretti Giuseppe decano di Oderzo
- Nardi Carlo
- Padovan Carlo Simeone
- Palatini Leopoldo
- Paludetto Franz
- Prosdocimo Giorgio Domenico
- Querini Benzon Marina
- Rocco Lepido
- Rolleri Bevilacqua Angelita
- Roma Gina
- Sabbionato Bartolomeo
- Scarpa Antonio
- Serato Massimo
- Soletti Pietro
- Tagliapietra Pilade
- Talier Angelo Natale
- Tiziano di Oderzo
- Tomitano Giulio Bernardino
- Tomitano Pompeo
- Vietri Tullio
- Vizzotto Alberti Enrico
- Vizzotto Alberti Giuseppe
- Zanardo Aldo
- Personaggio dell'anno
- Trevigiani illustri
- Ricerche in corso
- Personaggi in primo piano
- Tra Piave e Livenza
- Territorio Ambiente Paesaggio
Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza
- Home
- Storia Economia Società
- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto
- Archeologia
- Venetkens | Veneti antichi
- Civiltà romana
- Le origini di Venezia
- Il Veneto nel Medioevo
- La Repubblica veneziana
- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli
- La fine della Repubblica veneziana
- Veneto e Risorgimento
- La cessione del Veneto all'Italia
- Il Veneto dopo l'Unità
- Emigrazione
- Ebraismo nel Veneto
- Grande Guerra
- Fascismo e Resistenza
- Società veneta contemporanea
- Accadde oggi
- Cultura
- Personaggi
- Personaggi in primo piano
- Agostinetti Giacomo (Jacopo)
- Albrizzi Almorò
- Aleandro Girolamo
- Aleandro Girolamo il Giovane
- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)
- Amalteo Francesco
- Amalteo Pomponio
- Angeli Antonio
- Belli Bortolo
- Benvenuti Arturo
- Beretti Valentico Adriano
- Bernardi Mario
- Bernardi Ulderico
- Bevilacqua Giuseppe
- Borsato Gino
- Bottero Antonio
- Brusatin Angelo
- Bucciol Eugenio
- Buso Armando
- Cadamuro Olga Olimpia
- Caligiuri Clelia
- Capitone Gaio Voltejo
- Caramel Angelo "Elo"
- Caramel Giacomo
- Carrer Giovanni Battista
- Casoni Francesco Opitergino
- Casoni Guido
- Cecchetti Raimondo
- Chinazzo Daniele
- Cibin Luigi Pompeo
- Ciganotto Lodovico
- Colao Lucia
- Colombo Michele
- Costariol Dino
- Cristofoletti Ciro ed Eugenio
- Dal Pozzo Pietro
- Dall'Ongaro Francesco
- Dall'Oste Luigi
- Dall'Oste Pietro
- Dal Sasso Severino
- Daniotti Sanfiore Francesco
- Darzino (Caramel) Bruno
- De Domini Giampietro
- Donadon Tiburzio
- Erler Giulio Ettore
- Erler Tino
- Floriano di Oderzo
- Furlan Antonio
- Gardin Antonio
- Gini Corrado
- Girardini Giovanni
- Kuzminac Goran
- Lippi Giuseppe
- Lozer Giuseppe
- Luchesi Andrea
- Lunardelli Geremia
- Luzzatti Luigi
- Magno di Oderzo
- Mantovani Gaetano
- Manzoni Domenico
- Martini Alberto
- Melchiori Francesco
- Mengaldo Angelo
- Molmenti Pompeo Marino
- Montemezzo Antonio
- Moretti Giuseppe decano di Oderzo
- Nardi Carlo
- Padovan Carlo Simeone
- Palatini Leopoldo
- Paludetto Franz
- Prosdocimo Giorgio Domenico
- Querini Benzon Marina
- Rocco Lepido
- Rolleri Bevilacqua Angelita
- Roma Gina
- Sabbionato Bartolomeo
- Scarpa Antonio
- Serato Massimo
- Soletti Pietro
- Tagliapietra Pilade
- Talier Angelo Natale
- Tiziano di Oderzo
- Tomitano Giulio Bernardino
- Tomitano Pompeo
- Vietri Tullio
- Vizzotto Alberti Enrico
- Vizzotto Alberti Giuseppe
- Zanardo Aldo
- Personaggio dell'anno
- Trevigiani illustri
- Ricerche in corso
- Personaggi in primo piano
- Tra Piave e Livenza
- Territorio Ambiente Paesaggio
- Sei qui:
-
Home

-
Storia Economia Società

- La Repubblica veneziana
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 1190
Appuntamento di AltoLivenzaFestival col libro "Un regno tra la Terra e il Cielo. L'avvincente storia dell'ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia" di Lucio Pertoldi (in collaborazione con Roberto Tirelli, foto di Stefania Minzoni, illustrazioni di Nicola Zaramella, Alessandro Concina, Marco Moisé).
DOVE? Alla Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri, a Prata di Pordenone, Giovedi 24 novembre alle ore 20.30
Oltre all'autore Lucio Pertoldi che accompagnerà il pubblico alla scoperta del Patriarcato di Aquileria con una video-lettura, lo storico Luigi Zanin tratterà degli antichi Signori di Prata.

- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 1401
È stato recentemente pubblicato il libro di Alice Barro Paneghel (psicologa e presidente dell’associazione AiutoDonna di Oderzo) e Raffaella Pea, Repubblica di Venezia. Donne veneziane pioniere del diritto allo studio e al lavoro, per una cultura delle pari opportunità, Gianni Sartori Editore, 2022. Su questo testo, sabato 26 novembre alle ore 17, in sala consiliare di Motta di Livenza, è stata organizzata un’occasione di dibattito su “Repubblica di Venezia: tempi e luoghi di emancipazione femminile”.

Oltre all’inquadramento del diritto veneziano a tutela delle donne (Lazzaro Marini) e alla presentazione del libro-antologia (Raffaella Pea), Maria Teresa Tolotto si soffermerà su dei documenti veneziani d’epoca (dagli archivi del Museo Correr) e in particolare sulla querela di Elisabetta Contarini nel 1682 per rivendicare una eredità. È un corposo dossier (di 78 pagine) da cui si ricavano non soltanto gli interessi economici in causa ma anche i maltrattamenti che essa subì nei pochi mesi che visse con il marito, certo Pietro Morosini. Elisabetta Contarini, nata il 17 agosto 1663, rimasta orfana di entrambi i genitori a soli tre anni, vivrà con una zia paterna in un convento di Padova e morirà il 25 maggio del 1681 … a quasi tre mesi dal matrimonio celebrato il 1° marzo di quello stesso anno.
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 1563
Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica - Identità e peculiarità
Convegno 6-9 marzo 2013 - Venezia, Palazzo Franchetti
promosso da: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Österreichische Akademie der Wissenschaften, VISCOM (Visions of Community), Austrian Science Fund FWF, Regione del Veneto, Università Ca’ Foscari, Centro Tedesco di Studi Veneziani | istitutoveneto.it
Sul cartiglio di San Gerolamo, un altro messaggio fa un appello agli “Avogadori”, che difendevano i diritti della Repubblica e quelli dei suoi cittadini: «Non condannate nessuno se siete in colera», si legge.
Infine, sul cartiglio di Sant’Agostino: «Quando punite gli sbagli degli esseri umani, date più peso alla vostra mitezza e bontà che alla gravità del delitto».
Il Leone di San Marco, simbolo del evangelista Marco, compare nella grande maggioranza dei dipinti di Palazzo Ducale, anche se, ci sono solo tre raffigurazioni del leone alato di gran formato: il Leone di San Marco di Jacobello del Fiore (1415), quello appena illustrato di Donato Bragadin (1459) e quello di Vittore Carpaccio (1465 c.-1525/26) | MUVE Palazzo Ducale
Registrazione video del convegno
Il Commonwealth veneziano - La dimensione diacronica - parte 1
Il Commonwealth veneziano - La dimensione diacronica - parte 2
Il Commonwealth veneziano - La dimensione diacronica - discussione
Il Commonwealth veneziano - Lo stato in funzione. Strutture di comando ... - parte 1
Il Commonwealth veneziano - Lo stato in funzione. Strutture di comando ... - parte 2
Il Commonwealth veneziano - Lo stato in funzione. Comunicazione, trattative ... - parte 1
Il Commonwealth veneziano - Lo stato in funzione. Comunicazione, trattative ... - parte 2
Il Commonwealth veneziano - Lo stato in funzione. Comunicazione, trattative ... - discussione
Il Commonwealth veneziano - Lo stato debole. Terraferma fra mare e terra - parte 1
Il Commonwealth veneziano - Lo stato debole. Terraferma fra mare e terra - parte 2
Il Commonwealth veneziano - Lo stato debole. Terraferma fra mare e terra - discussione
Il Commonwealth veneziano - Spazi di movimento, confronto e controllo ... - parte 1
Il Commonwealth veneziano - Spazi di movimento, confronto e controllo ... - parte 2
Atti del Convegno
Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, Ermanno Orlando, Atti del Convegno 3-6 marzo 2013, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia, 2015 | istitutoveneto.it/.../pdf?mode=download | Leggi pdf
Gherardo Ortalli, The Genesis of a Unique Form of Statehood, between the Middle Ages and the Modern Age
Gian Maria Varanini, I nuovi orizzonti della Terraferma
Monique O’Connell, The Contractual Nature of the Venetian State
David Jacoby, The Expansion of Venetian Government in the Eastern Mediterranean until the Late Thirteenth Century
Luciano Pezzolo, La costituzione fiscale dello Stato veneziano
Benjamin Arbel, Una chiave di lettura dello Stato da mar veneziano nell’Età moderna: la situazione coloniale
Egidio Ivetic, Territori di confine (secoli XV-XVIII)
Oliver Jens Schmitt, «Altre Venezie» nella Dalmazia tardo-medievale? Un approccio microstorico alle comunità socio-politiche sull’isola di Curzola/Korčula
Alessandra Rizzi, Dominante e dominati: strumenti giuridici nell’esperienza ‘statuale’ veneziana
Nicolas Karapidakis, Dominants et dominés dans le Levant vénitien: les zones d’ombre des identités
Guillaume Saint-Guillain, Protéger ou dominer? Venise et la mer Égée (XIIIe-XVe siècle)
Thierry Ganchou, Sujets grecs crétois de la Sérénissime à Constantinople à la veille de 1453 (Iôannès Tortzélos et Nikolaos Pôlos): une ascension sociale brutalement interrompue
Serghei Karpov, Colonie o capisaldi. Verso Tana, Trebisonda e il Mar Nero, secc. XIV-XV
Paolo Preto, «Causar la morte di questo tristo» fa «un gran bene alla nostra patria»
Eric Dursteler, «Portare San Marco nel cuore». Strategie di integrazione all’interno della nazione veneziana a Istanbul
Piero Del Negro, L’esercito e le milizie
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2190
Filippo Pigafetta (1533-1604)


Andrea Savio, Tra spezie e spie. Filippo Pigafetta nel Mediterraneo del Cinquecento, Viella, Roma, 2020 | Reperibilità: torrossa.com/4692175
Il nobile vicentino Filippo Pigafetta (1533-1604), parente del più famoso Antonio, fu a sua volta instancabile viaggiatore, figura emblematica tra politica, affari e cultura del Cinquecento. Il volume ne descrive le peregrinazioni compiute nel decennio 1576-1587 tra Suez, Londra, Madrid, Lisbona, Roma, Gerusalemme e Venezia, come esploratore, cartografo, informatore, poligrafo e diplomatico tra il mondo cristiano e quello ottomano, e lo segue, un'udienza dopo l'altra, per le corti di Filippo II, Elisabetta I, papa Sisto V e Ferdinando I de' Medici. Lo scopre, infine, per un momento, perno di una possibile alleanza tra le potenze europee per il controllo dell'Egitto, in vista dell'apertura di un canale a Suez per il transito del pepe indiano dal Mar Rosso al Mediterraneo.
Antonio Di Lorenzo, Il vicentino che tre secoli prima voleva aprire il canale di Suez, 6.10.2020 | antoniodilorenzo.it
C’è un vicentino che trecento anni prima dell’apertura del canale di Suez (1869) aveva proposto a papi e sovrani europei di tagliare l’istmo e collegare il Mediterraneo al Mar Rosso. L’antesignano del mega progetto è Filippo Pigafetta (1533-1604) che sbrigativamente si può definire un faccendiere del sedicesimo secolo, vista la molteplicità dei suoi interessi e degli affari che concludeva. In realtà fu un instancabile viaggiatore, ma anche un esploratore, un cartografo e soprattutto una spia. Però è meglio levarsi dalla mente Sean Connery e 007: la sua vita si svolgeva su altri binari. Era parente alla lontana del più celebre Antonio Pigafetta, che peraltro era già morto quando lui nacque. Lui lo indicava come uno zio.
A Filippo Pigafetta il giovane studioso Andrea Savio, 34 anni, dottore di ricerca in scienze storiche che insegna all’università di Padova, ha dedicato il suo ultimo libro: “Tra spezie e spie – Filippo Pigafetta nel Mediterraneo del Cinquecento”. Savio ha dedicato sette anni di studio a questa ricerca, recandosi anche in talune delle città toccate da Pigafetta per esplorare archivi pubblici e privati. Pubblicato da Viella, in quasi 170 pagine il libro racconta dieci anni delle peregrinazioni del Nostro, che tra il 1576 e il 1587 fa tappa a Suez, Madrid, Londra, Lisbona, Roma, Gerusalemme e Venezia.
Opere di Filippo Pigafetta
- [1591] Relatione del reame di Congo et delle circonvicine contrade, tratta dalli scritti e ragionamenti di Odoardo Lopez portoghese per Filippo Pigafetta [...], Appresso Bartolomeo Grassi, Roma, 1591, [Bibliothèque nationale de France] | gallica.bnf.fr/bpt6k105751 | e-rara.ch/download | Leggi pdf | Biblioteca pubblica di Lione: books.google.fr/-aurfsHGclwC | The Online Books Page - Online Books by Filippo Pigafetta
- [1591] Filippo Pigafetta, Relatione dell'assedio di Parigi, col dissegno di quella città, e de' luoghi circonvicini. Alla Santità di Nostro Signore Gregorio PP. XIIII, Per Giovanni Rossi, Bologna, MDXCI (1591) [digitalizzato da Bibliothèque nationale de France] | gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8407964
- [1586] Filippo Pigafetta, Discorso d'intorno all'historia della Aguglia, et alla ragione del muoverla, Appresso Bartolomeo Grassi, Roma, MDLXXXVI (1586) [digitalizzato da Bibliothèque nationale de France] | openmlol.it/media/filippo-pigafetta | books.google.it/8T--HnFYhf8C [digitalizzato da Biblioteca Universitaria di Torino] | books.google.it/yDqs67a7JvwC [digitalizzato da Biblioteca Nazionale Centrale di Roma] | books.google.it/XJaNx2t1XQEC [digitalizzato da Biblioteca Casanatense] | arachne.uni-koeln.de/ZID713910
- [1586] Trattato brieve dello schierare in ordinanza gli eserciti et dell'apparecchiamento della guerra, di Leone, per la gratia di Dio imperatore. Nuovamente dalla greca nella nostra lingua ridotto da M. Filippo Pigafetta. Con le annotationi del medesmo ne'luoghi, che n'hanno mestieri, Appresso Francesco de' Franceschi senese, Roma, 1586 | books.google.it/srDvaQu0iHgC
- Guido Ubaldo dei Marchesi del Monte, Le meccaniche tradotte in volgare dal sig. Filippo Pigafetta, Presso il Franceschi, 1581 | cicognara.org/catalog/925
- Noémie Castagné, Martin Frank, Definizione dell’italiano scientifico nel tardo Cinquecento: la traduzione del Mechanicorum Liber di Guidobaldo dal Monte, pp. 279-308 | doi.org/laboratoireitalien | journals.openedition.org/laboratoireitalien
- Lettera di Filippo Pigafetta nobile vicentino descrittiva il Teatro Olimpico e la rappresentazione in esso fatta dell'Edipo di Sofocle nel 1585, Edizione terza, Tipografia Picutti Edit., Vicenza, 1843 | books.google.it/J3eG78Whx58C [digitalizzato da Biblioteca di Cremona]
- Relatione et discorso della corte, et governo del Re di Spagna di Filippo Pigafetta in Madrid (manoscritto), in Notizie istoriche appartenente al Regno di Spagna, di Portogallo, e di Sicilia, 1543-1611 | nla.gov.au/888397713 | nla.gov.au/24773059
- Pierfederico Gariglio, A proposito di Ludovico Scamozzi e delle sei lettere inviate da Filippo Pigafetta a Joost Lips | sfogliami.it
Filippo Pigafetta, Novam hanc et accuratissimam Territorii Vicentini descriptionem a cla. me Philippo Pigafetta pridem amplitudini esius destinatama L. M. Q. DD. humill. observantiae ergo Ioannes Baptista Vrintius Antuerp.
Riferimenti
- Daria Perocco, Pigafetta Filippo, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 83 (2015) | treccani.it/filippo-pigafetta_(Dizionario-Biografico) | it.wikipedia.org/Filippo-Pigafetta
- Filippo Pigafetta, in Pietro Donazzolo, I viaggiatori veneti minori, Studio bio-bibliografico, Memorie della Reale Società Geografica Italiana, vol. XVI, Alla Sede della Società,Tipografia Ditta Ludovico Cecchini, Roma, 1924, pp. 154-158 | asa.archiviostudiadriatici.it/islandora/.../libria_316804.pdf | Leggi pdf
- Paola Zanovello, Alessandra Menegazzi, Dalle ricerche di Carlo Anti al Progetto EgittoVeneto, pp. 95-99, in Antichità egizie e Italia. Prospettive di ricerca e indagini sul campo, Atti del III Convegno Nazionale Veneto di Egittologia, Ricerche sull’antico Egitto in Italia, a cura di Emanuele M. Ciampini, Paola Zanovello, Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, Venezia, 2014 | culturaveneto.it/egittoveneto
«La tradizione delle ricerche venete in Egitto Il Veneto e Padova hanno un legame antico con l’Egitto, che risale alle prime relazioni documentate in epoca romana, ma soprattutto ai secoli dei viaggiatori e degli esploratori: Venezia in particolare tra XV e XVI secolo produsse una serie di importanti documenti cartografici, dal Planisfero di Fra’ Mauro (1459), che mostra un Mediterraneo "rovesciato" rispetto alla moderna concezione geografica, alle carte prodotte da Giovan Battista Ramusio (1550), Giacomo Gastaldi (1545-1564), Livio Sanuto (1588), agli atlanti nautici di Battista Agnese (1554), Giorgio Sideri (1563). Altri centri veneti diedero i natali a molti viaggiatori, con interessi specifici verso il mondo egiziano: dal bellunese Giovanni Pietro Dalle Fosse, meglio noto con lo pseudonimo di Pierio Valeriano, che propose una sua interpretazione dei geroglifici (pubblicata nel 1556), ad un anonimo veneziano che nel 1589 risalì il corso del grande fiume e ne restituì una circostanziata descrizione manoscritta, ora alla Biblioteca Nazionale di Firenze, al vicentino Filippo Pigafetta, che produsse, a seguito di ripetute permanenze in Egitto, una grande carta del corso del Nilo (pubblicata nel 1591)», p. 95.
- Teobaldo Filesi, Sulla pubblicazione d'un grande inedito di Filippo Pigafetta: la Relatione "Viaggio dell'Egitto, dell'Arabia, del Mar Rosso et del Monte Sinai", «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», Anno 45, No. 2 (GIUGNO 1990), pp. 281-300 | jstor.org/40760520
- Si presenta in Bertoliana l'1 settembre il libro di Andrea Savio, Tra spezie e spie | comune.vicenza.it/notizie
- Filippo Pigafetta, pp. 128-140, in Gianluca Masi, I rapporti tra il Granducato di Toscana e il Principato di Transilvania (1540–1699), Tesi di dottorato, Tutor prof. Maria Pia Pedani, UniVe, 2013 | dspace.unive.it
- Mario Pozzi, Filippo Pigafetta e la lotta contro i Turchi nel 1601, Vita e Pensiero, Milano, 2005
- La Relatione Viaggio dell’Egitto, dell’Arabia, del mar Rosso et del Monte Sinai di Filippo Pigafetta, in Arturo Gallia, Circolazione e persistenza dei saperi geografici in età moderna. La descrizione del Nilo nella letteratura scientifica e odeporica, pp. 157-179, «Geostorie. Bollettino e Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici», Anno XXIII – n. 3 Settembre-Dicembre 2015 | cisge.it/geostorie/article | Leggi pdf
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2865
Il 31 ottobre del 1517 Martin Lutero, monaco agostiniano, da tre anni professore di teologia all'università di Wittenberg (in Turingia), affisse sulla porta della chiesa del castello di questa città un documento con 95 tesi in cui criticava la prastica della vendita delle indulgenze e il ruolo delle autorità ecclesiastiche, in particolare del Papa.
L'affissione di un tale documento doveva precedere una pubblica assemblea in cui Lutero avrebbe difeso le proprie affermazioni, una prassi allora corrente nei centri universitari. Alcuni storici sostengono invece che le 95 tesi furono inviate, in quel giorno, ai vescovi interessati e che furono diffuse solo dopo la mancata risposta dei vescovi.
Anche se non sembrano esserci prove certe né per l'una né per l'altra versione dei fatti, il 31 ottobre 1517 è, in ogni caso, considerato l'inizio della riforma protestante (← Davide Maria De Luca, La riforma protestante iniziò con una notizia falsa?, «ilpost.it», 31.10.2017 | ilpost.it/lutero-95-tesi)

Non è qui la sede per riandare alla storia della Riforma luterana e della Controriforma cattolica, sulle quali esiste una sterminata serie di studi lungo i secoli. Peraltro nel 2017, in occasione del Cinquecentenario, c'è stato un fiorire di convegni, anche interconfessionali, e di pubblicazioni, che hanno rianimato il confronto storico e culturale. Merita invece ricordare come nei territori della Repubblica veneziana si diffuse la Riforma e si tentò di reprimerla e rintuzzarla. Com'è interessante richiamare personaggi che hanno agito nel nostro territorio ed eventi che hanno coinvolto le nostre comunità nel XVI e XVII secolo:
Girolamo Aleandro (Motta di Livenza, 1480 - Roma, 1542)
Fu inviato in qualità di nunzio pontificio in Germania (1520) per pubblicare e far eseguire la bolla papale Exsurge Domine, ed ottenne, nella dieta di Worms (1521), la messa al bando di Lutero.
La Bulla contra errores Martini Lutheri et sequentium di papa Leone X, altresì detta Exsurge Domine, pubblicata il 15 giugno 1520, costituiva la risposta con cui la Chiesa cattolica condannava sia le Novantacinque Tesi sia gli scritti di Martin Lutero successivi. Oltre a pretendere ufficialmente la ritrattazione, entro sessanta giorni, di 41 delle sue 95 tesi e di altri errori indicati nello specifico, si vietava in tutti i paesi cattolici la stampa, la vendita e la lettura di qualsiasi libro che contenesse gli errori e le eresie esposte nelle 95 tesi e si richiedeva alle autorità secolari il rispetto e l'applicazione di quanto espresso, nei loro domini.
- Una sezione del nostro sito è dedicata alla biografia e alle opere di Girolamo Aleandro.
Adriano Beretti Valentico (Valentigo, Oderzo, 1506 - Capodistria, 1572)
Al secolo Girolamo Beretti, mutò il nome in Adriano quando nel 1523 entrò nell'ordine domenicano, facendo parte della comunità del monastero di S. Domenico di Castello in Venezia. "Valentico" è il soprannome che gli venne dato dal luogo d'origine (Valentigo, nel territorio di Oderzo), dove la madre Domenica aveva delle proprietà. Negli atti del concilio tridentino è citato come "Hadrianus Venetus".
Distintosi presto per la sua preparazione come teologo, fu incaricato dell'insegnamento della metafisica tomista all'università di Padova e di ermeneutica delle Sacre Scritture. È autore del Tractatus de inquirendis puniendisque haereticis (1542), del De Eucharistia adversus Calvinum e del Contra errores Matthaei Gribaldi (1559).
Per i contatti avuti con personalità eminenti del clero veneto, alcuni dei quali sospetti di eresia, come il patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani, e il vescovo di Chioggia, Iacopo Nacchianti, fu interrogato a Venezia nel dicembre del 1548 - in occasione del processo istituito contro quest'ultimo - da Angelo Massarelli, segretario del concilio di Trento, ma non fu mai sfiorato dal sospetto di eresia. Anzi, nel 1562 Pio IV lo nominò teologo al concilio di Trento dove intervenne durante le ultime sessioni sul sacramento dell'ordine e del matrimonio.
Dopo la conclusione del Concilio (1545-1563), fu nominato inquisitore a Venezia, con giurisdizione su tutto il territorio veneto, e nel 1566 fu insediato come nuovo vescovo di Capodistria per recuperare all'ortodossia cattolica la diocesi in cui qualche anno prima il vescovo Pier Paolo Vergerio aveva diffuso largamente i semi dell'eresia luterana prima della fuga e del suo clamoroso passaggio alla Riforma.
- Giovanni Pillinini, Beretti Adriano, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 9 (1967) | treccani.it/enciclopedia
- Beretti Adriano, Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, Edizioni CLORI, Firenze | ERETICOPEDIA - Mediterranean Digital & Public Humanities, ereticopedia.org/adriano-beretti
- Beretti Valentico Adriano | obrazislovenskihpokrajin.si
- Daniele Santarelli, Vergerio Pier Paolo, Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo, Edizioni CLORI, Firenze | ERETICOPEDIA - Mediterranean Digital & Public Humanities, ereticopedia.org/pier-paolo-vergerio
- Ugo Rozzo, Vergerio Pier Paolo il Giovane (1498-1565), Dizionario Biografico dei Friulani | dizionariobiograficodeifriulani.it/vergerio-pier-paolo-il-giovane
- Benedetto Nicolini, Vergerio Pietro Paolo il Giovane, Enciclopedia Italiana (1937) | treccani.it/enciclopedia
- Pietro Paolo Vergerio | it.wikipedia.org
Vincenzo Bertoldo di Oderzo (Oderzo, ? - Ceneda, 1570)
Fu sottoposto a processo da parte dell'Inquisizione di Ceneda a seguito di una denuncia presentata contro di lui l'8 agosto 1569. La sua casa ad Oderzo fu perquisita e vi fu rinvenuta una cassa con numerosi libri proibiti (tra questi, l'Opera omnia di Lutero).
Arrestato nell'aprile 1570 insieme al suo servo Cipriano, il suo processo fu condotto dal vescovo Michele Della Torre e dall'inquisitore di Ceneda Daniele Sbarrato. Detenuto a Ceneda nel castello di San Martino, Vincenzo Bertoldo affermò che i libri erano posseduti dal fratello prete Francesco Bertoldo, deceduto.
Poco dopo questa confessione (fatta in un interrogatorio svoltosi l'8 maggio 1570) Vincenzo morì improvvisamente in carcere, presumibilmente a causa di un colpo apoplettico, l'11 maggio 1570.
- Andrea Del Col, La morte dell’inquisito nel castello di Ceneda, 11 maggio 1570. Il processo contro Vincenzo Bertoldo, «Archivio Storico Cenedese», 1, 2015, pp. 45-82 | academia.edu/38444282
* * *
La Repubblica di Venezia era, fra gli stati italiani più grandi e potenti del Cinquecento, l’unico in grado di competere con le grandi potenze come la Francia o la Spagna sullo scacchiere politico, diplomatico e militare europeo, nonché uno dei più vivaci e liberi sul piano culturale, artistico, letterario, filosofico. Fu anche lo Stato italiano in cui le idee della Riforma protestante ebbero il maggiore successo, rischiando di destabilizzare il suo stesso equilibrio politico e generando talvolta aspri conflitti con Roma sulle modalità e sulle competenze della persecuzione degli eretici.
La diffusione delle idee della Riforma fu favorita dall'ampia circolazione di libri eterodossi a Venezia sin dagli albori del dissenso luterano. Non va dimenticato che Venezia era una delle capitali dell’industria e del mercato librario. La cospicua presenza di mercanti tedeschi, gravitanti intorno al loro Fondaco, non poteva che favorire la circolazione delle opere di Lutero, che si potevano trovare nelle botteghe dei librai sin dal 1520. La città non fu solo un ambito di intensa circolazione ma anche un luogo d’edizione privilegiato dei principali testi attraverso i quali le idee della Riforma penetrarono in Italia. (si veda più estesamente, a tal proposito, in ERETICOPEDIA - Mediterranean Digital & Public Humanities, il testo di Daniele Santarelli Riforma protestante nella Repubblica di Venezia)
Per saperne di più
- [2020] Gianmarco Braghi, La riforma nel Cinquecento e i suoi "eretici per tutti", «Nuova Secondaria», Mensile di cultura, ricerca pedagogica e orientamenti didattici, n. 10, Giugno 2020, Anno XXXVII, pp. 36-38 | books.google.it/ya7vDwAAQBAJ
- [2017] Giacomo Gambassi, La Riforma. 500 anni fa Lutero pubblicava le sue 95 Tesi. Ecco che cosa dicono, «Avvenire.it», 31 ottobre 2017 | avvenire.it/chiesa/95-tesi-di-lutero-riforma
- [2017] Wim François, The Protestant Reformation North of the Alps, in Rivoluzione, riforma, transizione, Atti della Summer School 2017, A cura di Alberto Barzanò e Cinzia Bearzot, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica, Milano, 2018, pp. 311-332 | system.educatt.com/libri
- [2017] Riforma e riforme nel Nordest: rileggere la complessità, «Facoltà Teologica del Triveneto» | fttr.it/riforma-e-riforme-nel-nordest-rileggere-la-complessita | isevenezia.it/500-dalla Riforma-protestante
- [2017] Giulio Dalla Grana, Venetia sarà la porta. Riforma ed eresia nella repubblica di Venezia nel secolo XVI, Tesi di laurea triennale, UniPd, 2016/2017, Relatore prof. Liliana Billanovich | thesis.unipd.it/.../tesi_gdg
- [2017] Dino Carpanetto, Cinquecento anni dalla Riforma protestante, «it.pearson.com/storia» | Leggi pdf
- [2016] Lucia Felici, La Riforma protestante nell’Europa del Cinquecento, Carocci editore, Roma, 2016 | flore.unifi.it/.../2158/1074739
- [2015] Eresie nel vicentino: gli anabattisti | accogliamoleidee.wordpress.comeresie-nel-vicentino-gli-anabattisti
- [2011] Silvana Seidel Menchi, Serena Luzzi, L'Italia della Riforma, l'Italia senza Riforma, Cristiani d'Italia (2011) | treccani.it/enciclopedia
- [2007] Federica Ambrosini, I reticolati del dissenso e la loro organizzazione in Italia, pp. 87-103, [books.openedition.org/efr/1722] in Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi, Alain Tallon, La Réforme en France et en Italie, Publications de l’École française de Rome, 2007 | books.openedition.org/efr/1696
- [2007] Susanna Peyronel Rambaldi, Propaganda evangelica e protestante in Italia (1520 c.-1570), pp. 53-68 [books.openedition.org/efr/1717], in Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi, Alain Tallon, La Réforme en France et en Italie, cit.
- [s.d] Daniele Santarelli, Riforma protestante nella Repubblica di Venezia, «Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo», Edizioni CLORI, Firenze | ereticopedia.org/riforma-protestante-venezia | Chi è Daniele Santarelli: letterebeniculturali.unicampania.it | unina2.academia.edu/DanieleSantarelli
- [s.d.] Daniele Santarelli, L'anabattismo veneto | ereticopedia.org/anabattismo-veneto
- [s.d.] Storia della Riforma e della Controriforma a Vicenza | it.wikipedia.org
- [s.d.] La Riforma Luterana nella Repubblica Veneta, Foresteria Valdese Venezia | foresteriavenezia.it/Valdesi-e-metodisti-a-Venezia
- [s.d.] I Valdesi a Venezia | venezia.chiesavaldese.org/.../storia-chiesa-valdese-e-metodista-a-venezia
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2102
È disponibile sull'argomento un'interessante monografia di Alessandra Minotto, elaborata come tesi di dottorato.
La ricerca parte dall’esigenza di considerare le acque e l’incolto non solo come risorse naturali ed economiche (incolto produttivo), e conseguentemente come elemento importante per gli equilibri socio-economici delle società rurali, ma anche come risorse, occasioni, problemi di carattere politico nel senso lato del termine: si tratti di politica “inter-statuale” o di politica “intra-statale”, vale a dire di rapporti tra centro e periferia. Spesso infatti gli spazi incolti fungono anche da sorta di membrana-confine tra uno stato e un altro o tra diverse comunità, e lo studio dell’incolto si inserisce all’interno di più ampie discussioni storiografiche sul tema delle frontiere percepite in tutte le loro sfumature (politiche, economiche, giuridiche e giurisdizionali, naturali). Di conseguenza, analizzare la diffusione e lo sfruttamento, o la riduzione, di tali risorse significa anche esaminare le dinamiche giurisprudenziali atte a regolarne l’utilizzo.
L’analisi è stata condotta entro i confini geografici coincidenti con le terre della gronda lagunare meridionale di Venezia nel periodo storico che va dalla fine del Medioevo agli inizi dell’età moderna. Tra le parti in causa compaiono monasteri, comunità rurali ed esponenti dell’aristocrazia veneziana, variamente coinvolti – l’intreccio è sempre molto stretto – in questioni confinarie e in strategie di accaparramento delle risorse. In particolare, il peso giocato dagli enti ecclesiastici veneziani – fruitori e detentori di boschi, acque e valli – nelle controversie provocate da usi differenti dell’ambiente incolto perilagunare è importante, in un momento nel quale la rilevanza economica di questo ambiente appare crescente. Va segnalato infine che buona parte delle fonti proviene dagli archivi monastici, e ciò pone delicati problemi di metodo che vengono discussi nell’elaborato.
- Alessandra Minotto, Lavorare l’acqua e la terra. L’incolto produttivo nella gronda lagunare di Venezia alla fine del Medioevo, Tesi di dottorato, Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea, Ciclo XXV, UniVe, 2014, Coordinatore prof. Mario Infelise, Tutor prof. Gian Maria Varanini | iris.unive.it/.../Minotto.pdf | Leggi in pdf
Bibliografia / Sitografia
Altri testi di Alessandra Minotto
- [2015] Alessandra Minotto, Una prospettiva regionale? Le campagne del Veneto tardo medievale nella medievistica italiana degli ultimi decenni, «Archivio Veneto», Sesta serie, n. 10, 2015, pp. 139-186 | academia.edu/15348534
- [2015] Alessandra Minotto, Tra le carte dei monaci. Mappe, disegni, strumenti e tecniche per il rilievo topografico del territorio veneziano, «Ateneo Veneto», CCII, terza serie, 14/II (2015), pp. 37-61 | academia.edu/28171628
- [2014] Alessandra Minotto, Raccontare, disegnare, incidere l'acqua e la terra. Storie di geografia popolare nella laguna meridionale di Venezia nel Medioevo, in Les zones humides méditerranéennes hier et aujourd'hui / Le zone umide mediterranee ieri e oggi, a cura di Daria Quatrida e Remy Simonetti, Magalie Franchomme e Cristine Labeur, Padova University Press 2014, pp. 29-44 | academia.edu/7739178
- [2005] Alberto Sciretti, Il paesaggio della Gronda della laguna Nord, Tesi di laurea, UniVe, 2004-2005, Relatore prof. Francesca De Meo | sciretti.it/tesi.pdf | Sono comprese anche due utili Appendici sulla fotografia di paesaggio e sul paesaggio nell’arte pittorica.
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2398
L'editoria veneziana conobbe nella prima metà del XVIII secolo una progressiva espansione, dopo i momenti di crisi attraversati nel secolo XVII «irto di conflitti e di difficoltà». Nella seconda metà del Seicento fu la pubblicazione di libri soprattutto sacri, liturgici e non liturgici (ma anche scolastici, di medicina, di giurisprudenza) a tenere ancora redditiziamente Venezia dentro il mercato per l'orbe cattolico (non va dimenticato che la cultura è ancora quasi monopolio di monaci e "abati") e su tali tipologie editoriali continuarono a puntare gli imprenditori tipografici e librari nel nuovo secolo, incamminandosi risolutamente - fattore tutt'altro che secondario - nella direzione dell'eleganza e della raffinatezza dei loro prtodotti. [Ampia trattazione di questi temi si legge in Marino Zorzi, L'ultima fase della Serenissima - Cultura e civiltà: La stampa, la circolazione del libro, Storia di Venezia (1998) | treccani.it/enciclopedia].
Contemporaneamente, la stampa veneziana perseguiva un'altra direttrice di sviluppo, destinata a straordinario successo: quella dell'editoria illustrata, come nel 1703 la raccolta di centoquattro acqueforti dell'artista friulano Luca Carlevariis, Le fabbriche e vedute di Venetia, «un capolavoro artistico e tipografico», e nel 1708-1709 due imponenti volumi del frate cosmografo Vincenzo Coronelli, intitolati Singolarità di Venezia, e del serenissimo suo dominio: chiese, palazzi, monasteri, conventi e altri luoghi di Venezia, raffigurati in oltre seicento incisioni (di qualità grafica modesta ma di grande interesse documentario).
Il successo di tali raccolte indusse alcuni patrizi, riuniti attorno al cancellier grande Giovan Battista Nicolosi, a fondare un'accademia col proposito di riprodurre le bellezze della città incomparabile in una serie di incisioni, ma poi preferirono cedere l'iniziativa a un editore professionista, Domenico Lovisa, che per riuscire nell'opera lanciò una sottoscrizione nel 1715. Nel 1717 usciva in due tomi Il gran teatro di Venezia, ovvero raccolta delle principali vedute e pitture che in essa si contengono, con centoventi incisioni, riedito nel 1720.
Nel filone delle raccolte di incisioni aventi ad oggetto le opere d'arte cittadine aperto dal Carlevariis e dal Lovisa si inseriva felicemente nel 1726 l'Iconografia della Ducal Basilica, in cui Antonio Visentini faceva incidere da padre Vincenzo Mariotti una serie di propri disegni riguardanti la chiesa di S. Marco.
Al Lovisa venne affidata la stampa anche della collana degli Istorici delle cose veneziane che hanno scritto per pubblico decreto, una raccolta di grande prestigio, il cui primo titolo, contenente l'opera del Sabellico, uscì nel 1718. L'anno stesso uscì il secondo tomo, con l'opera del Bembo, seguirono nel 1719 le storie di Paolo Paruta e di Andrea Morosini, sinché nel 1722 si giunse, con l'opera di Michele Morosini, al decimo e ultimo tomo.
«Quando, attorno al 1730, i due grandi filoni, quello dell'editoria illustrata e quello delle opere di grande mole e impegno, si fusero, la stampa veneziana toccò il suo culmine qualitativo e giunse al massimo del suo successo».
- Le fabbriche e vedute di Venetia disegnate, poste in prospettiva et intagliate da Luca Carlevarijs con privilegii | Stampe - Fondo Corsini | calcografica.it/stampe
- Vincenzo Coronelli, Singolarità di Venezia, e del serenissimo suo dominio | internetculturale.it/opencms | culturaitalia.it/opencms
Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico Decreto: cioè Marc’Antonio Sabellico, Pietro Bembo, Paolo Paruta, Andrea Morosini, Battista Nani, Michele Foscarini.






Noi Reformatori dello Studio di Padova. Concediamo licenza a Domenico Lovisa, che possa ristampare i Libri infrascritti giusto gli esemplari stampati in questa Città ne gli anni in essi annotati
Marc' Antonio Sabellico stampato nell’anno 1487.
Pietro Bembo 1551.
Paolo Paruta 1605.
Andrea Morosini 1623.
Battista Nani 1662, & 1679.
Michel Foscarini 1696.
Dat. li 28. Marzo 1718.
( Francesco Soranzo Proc. Ref.
( Michel Morofini Ref.
( Lorenzo Tiepolo Kav. Proc. Ref.
Agostino Gadaldini Segret.
[I nomi dei curatori si ricavano da: p. XXIX del v. 1; p. I del v. 2; p. I del v. 3; p. [IX] del v. 5; p. I del v. 8; p. III del v. 10]
- (Istorie veneziane latinamente scritte da Marcantonio Coccio Sabellico)
[1718] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo primo, che comprende le Istorie veneziane latinamente scritte da Marcantonio Coccio Sabellico. Aggiuntavi la Vita dell'Autore, la Cronologia esatta nel margine, e Indici copiosi, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIII (1718) | ia800302.us.archive.org | Leggi pdf | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:14369 | Leggi pdf | books.google.it/okFAAAAAcAAJ | Leggi pdf
- (Istorie veneziane Latinamente scritte da Pietro Cardinale Bembo)
[1718] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo secondo, che comprende le Istorie veneziane Latinamente scritte da Pietro Cardinale Bembo. Aggiuntavi la Vita dell'Autore, la Cronologia esatta nel margine, e un indice copioso, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIII (1718) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:13437 | Leggi pdf | ia800204.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/books?id=BoRwWst5zs0C
- (Istorie veneziane volgarmente scritte da Paolo Paruta)
[1718] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo terzo, che comprende gli otto primi libri della prima parte dell'Istorie veneziane volgarmente scritte da Paolo Paruta, cavaliere proccuratore. Aggiuntavi la Vita dell'Autore, la Cronologia esatta nel margine, e indici copiosi, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIII (1718) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:24429 | Leggi pdf | ia800201.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/QnVUAAAAYAAJ | Leggi pdf
- (Istorie veneziane scritte da Paolo Paruta)
[1718] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo quarto, che comprende i quattro ultimi libri della parte prima, e la parte seconda dell'Istorie veneziane scritte da Paolo Paruta, cavaliere, e proccuratore. Aggiuntavi la Cronologia esatta nel margine, e Indici copiosi, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIII (1718) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:21938 | Leggi pdf | ia800904.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/BHZUAAAAYAAJ | Leggi pdf | books.google.it/0P5AAAAAcAAJ
- (Istorie veneziane latinamente scritte da Andrea Morosini)
[1719] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo quinto, che comprende i sei primi libri dell'Istorie veneziane latinamente scritte dal senatore Andrea Morosini. Aggiuntavi la vita dell'autore, e un indice copiosissimo, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIIII (1719) | ia802604.us.archive.org | Leggi pdf | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:314307 | Leggi pdf | books.google.it/HVZhAAAAcAAJ | Leggi pdf
- (Istorie veneziane latinamente scritte da Andrea Morosini)
[1719] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo sesto, che comprende i sei secondi libri dell'Istorie veneziane latinamente scritte dal senatore Andrea Morosini, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXVIIII (1719) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:19427 | Leggi pdf | ia802705.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/mz5AAAAAcAAJ | Leggi pdf
- (Istorie veneziane latinamente scritte da Andrea Morosini)
[1720] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo settimo, che comprende i sei ultimi libri dell'Istorie veneziane latinamente scritte dal senatore Andrea Morosini, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXX (1720) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:18806 | Leggi pdf | ia600703.us.archive.org | Leggi pdf
- (Istoria della Repubblica Veneta di Batista Nani)
[1720] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo ottavo, che comprende la parte prima dell'Istoria della Repubblica Veneta di Batista Nani, cavaliere e proccuratore. Aggiuntavi la Vita dell'Autore, e Indici copiosi, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXX (1720) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:17999 | Leggi pdf | ia802608.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/4j5AAAAAcAAJ | Leggi pdf | books.google.it/books?id=Q7nmlD5puXEC| Leggi pdf
- (Istoria della Repubblica Veneta di Batista Nani)
[1720] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo nono, che comprende la parte seconda dell'Istoria della Repubblica Veneta di Batista Nani, cavaliere e proccuratore. Aggiuntevi postille nel margine, e nel fine un Indice copioso, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXX (1720) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:20135 | Leggi pdf | books.google.it/2GxUAAAAYAAJ | Leggi pdf
- (Istoria della Repubblica Veneta di Michele Foscarini)
[1722] Degl'Istorici delle cose veneziane, I quali hanno scritto per Pubblico decreto, Tomo decimo, che comprende l'Istoria della Repubblica Veneta di Michele Foscarini, senatore. Aggiuntovi nel fine un Indice copioso, Appresso il Lovisa, Venezia, MDCCXXII (1722) | asa.archiviostudiadriatici.it/libria:22615 | Leggi pdf | ia802607.us.archive.org | Leggi pdf | books.google.it/gLcpAAAAYAAJ | Leggi pdf
Bibliografia
- [2023] Dorit Raines, Il patriziato veneziano tra eredità repubblicana e modelli monarchici, «Dimensione e problemi della ricerca storica», 2/2023, pp. 109-148 | rosa.uniroma1.it/.../dimensioni_ricerca_storica/article/download/1603/1444/5121
- [2014] Dorit Raines, La storiografia pubblica allo specchio. La “ragion di Stato” della Repubblica da Paolo Paruta ad Andrea Morosini, in Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell’identità veneziana nel tardo Cinquecento, a cura di Benjamin Paul, Roma, Viella, 2014, pp. 157-176 | academia.edu/6057313 | Leggi pdf
- [2014] Giulio Ferroni, Paruta Paolo, «Enciclopedia machiavelliana» (2014) | treccani.it/enciclopedia/paolo-paruta_(Enciclopedia-machiavelliana)/
- [1995] Gherardo Ortalli, I cronisti e la determinazione di Venezia, «Storia di Venezia» (1995) | treccani.it/enciclopedia/i-cronisti-e-la-determinazione-di-venezia_(Storia-di-Venezia)
- [1982] Francesco Tateo, Marcantonio Coccio, detto Marcantonio Sabellico, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 26 (1982) | treccani.it/enciclopedia/coccio-marcantonio-detto-marcantonio-sabellico_(Dizionario-Biografico)/
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2686
Tiziana Plebani, Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2012 | docenti.unimc.it/maria.ciotti/teaching | academia.edu/2434011 | Leggi pdf
Un vento caldo e potente soffia nel Settecento in tutta Europa. Consegna parole cariche di energia ai figli mentre svuota quelle dei padri. Un vento nutrito di cultura, romanzi e frequentazione dei teatri, che a Venezia rende sempre più audaci i figli e le figlie. In questo libro li seguiamo mentre scrivono lettere, inviano suppliche per liberarsi da padri dispotici, sorprendono i parroci con matrimoni clandestini, rincorrono una dispensa per nozze segrete, fuggono di casa. Si appropriano di saperi giuridici ed ecclesiastici, di informazioni pratiche e di notizie per riuscire a realizzare i propri desideri. I padri invece escogitano impedimenti, chiedono correzioni e progettano matrimoni forzati. Sono anni, atmosfere, idealità che masticano poco il linguaggio dell'ubbidienza e del sacrificio: il confronto tra le generazioni è ampio e senza esclusione di colpi. La posta in gioco è del resto la libertà di vita. Il terreno dello scontro è l'amore, che in questo secolo si conquista un prezioso alleato: la cultura assegna infatti all'amore il compito di creare una comunità rigenerata e migliore. E soprattutto felice.
Dal giudizio con cui la Commissione accoglie la pubblicazione del testo di Tiziana Plebani tra le Memorie dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti:
Tiziana Plebani desume questo lavoro dalla sua tesi di dottorato, discussa presso l'Università di Ca' Foscari e rielaborata per essere un libro, già preceduto da alcuni suoi articoli e saggi su argomenti particolari e su momenti della presenza femminile nella storia veneziana. Il titolo, efficace, potrebbe anche riuscire fuorviante e richiamare episodi di frivola vita settecentesca. Cercando di fare «storia dei sentimenti» l'autrice presenta invece in modo approfondito, attraverso lo studio di una miriade di casi concreti rilevati dai documenti, un aspetto della penetrazione delle idee illuministiche, attraverso infiniti tramiti, nella società veneziana e nell'ambito specifico della famiglia, non solo patrizia o cittadinesca, dove in conseguenza vacillano antichi principi e assetti consolidati, viene messa in crisi la predominante autorità paterna e si affievolisce la virtù dell'obbedienza. I figli e le stesse figlie non sono più disposti ad essere solo pedine della strategia economico-politica della famiglia e del casato, soggetti -salvo formale emancipazione -al padre o altri congiunti che ne decidono status e funzioni nella vita privata e pubblica, ma vogliono disporre di sé come persone autonome, libere di fare le proprie scelte per diritto naturale inalienabile. Di qui il conflitto tra generazioni. Banco di prova è l'incontro amoroso dei giovani, spesso con persone estranee alla propria condizione sociale e quindi doppiamente inviso, il loro cedere a un sentimento che vuol essere definitivo, mentre un tempo poteva essere proibito, represso come debolezza, o coltivato fuori dalle mura domestiche. L'autrice mette in rilievo gli accorgimenti escogitati dalle gene-relazione razioni in contrasto per raggiungere i propri scopi. Da parte paterna, talora il matrimonio del figlio con persona diversa dall'amata, rapidamente imposto e celebrato. Esauriti i tentativi di convinzione e correzione familiare, si poteva ricorrere all'autorità sia civile che ecclesiastica, sollecitando nella prima ipotesi mediante una supplicanoi diremmo una istanza o una denuncia -agli Inquisitori di Stato o ai Capi del Consiglio di dieci l'intervento dello State in questioni del tutto private. Questo si configurava, in crescendo, nell'ammonizione, arresti domiciliari, prigione, relegazione in qualche monastero o fortezza, anche in Terraferma, Dalmazia, Levante; trattamento a volte tanto severo che la stessa famiglia ne chiedeva l'attenuazione. Per converso i giovani rivolgevano suppliche per lamentare la durezza e l'incomprensione dei padri. Nei riguardi dell'autorità ecclesiastica, questi disponevano dello strumento della «contraddizione al matrimonio», diretta al parroco o all'Ordinario diocesano, che la poteva tuttavia sospendere o rimuovere, impedimento dirimente alle nozze anche in età legittima, talora predisposto a mero titolo cautelare e nei confronti di tutta la prole. Da parte dei figli, trovando le debite complicità, non esclusa quella materna, soluzioni estreme erano la fuga oppure il tentativo di matrimonio clandestino, di solito al momento della benedizione al termine della Messa, o il matrimonio segreto, di coscienza, omesse le pubblicazioni e non registrato nei comuni libri canonici, che liberava dal peccato ma non produceva effetti civili, salvo essere poi regolarizzato; fino all'improbabile approvazione dell' Avogaria di Comun non era comunque atto «a generar prole patrizia». Altri temi toccati dalla dott. Plebani meriterebbero di essere segnalati, ad esempio quello dell'atteggiamento del clero, sospeso tra riprovazione e comprensione della posizione giovanile. Notevole l'attenzione prestata dall'autrice alla veste linguistica dei documenti, in particolare quelli più spontanei, lettere biglietti, carteggi che ha potuto rinvenire, che lasciano a volte trapelare la lingua parlata. Il lavoro si distingue per l'ampia e accurata ricerca archivistica, svolta con competenza e rigore nei fondi deII'Archivio di Stato e dell'Archivio Storico del Patriarcato, facendo così dialogare fonti civili e fonti canoniche. Molto ricca la bibliografia, in varie lingue. L'esposizione è vivace e accattivante, numerose le citazioni documentarie. Piacciono X relazione soprattutto l'entusiasmo che l'autrice non riesce a celare, il gusto della ricerca, la gioia della scoperta, la confidenza con il documento, la simpatia per i protagonisti che tuttavia non intacca l'obiettività dello storico. .
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 3387
.jpg)
[a. m.] Le maggiori potenze europee (Sacro Romano Impero, Francia e Spagna) avevano formato il 10 dicembre 1508 la Lega di Cambrai (un centro del nord della Francia, ai confini col Belgio) contro la Repubblica di Venezia, decise a mantenere un'egemonia su diversi territori della penisola italiana e a spartirsi i domini veneziani. La cerchia dei nemici di Venezia era impressionante: Massimiliano I d'Asburgo (imperatore del Sacro Romano Impero), Luigi XII di Francia (re di Francia, Duca d'Orléans), Ferdinando II d'Aragona (re di Napoli e re di Sicilia), papa Giulio II (sovrano dello Stato Ecclesiastico), Alfonso I d'Este (duca di Ferrara), Carlo II (duca di Savoia), Francesco II Gonzaga (marchese di Mantova) e Ladislao II (re d'Ungheria).
Cinque mesi dopo, il 4 maggio 1509, le forze veneziane (ma dire veneziane significa "al soldo dei veneziani", poiché nessuna potenza in quel periodo storico teneva eserciti di leva e gli armati erano tutti mercenari, sia se provenienti dai propri domini interni sia se assoldati all'estero, cosicché la durata delle guerre era commisurata alla durata delle disponibilità economiche di pagarli) furono battute nella battaglia di Agnadello o della Ghiaradadda (Gera d'Adda). Non poco danno avevano arrecato le serie divisioni di concezioni strategiche emerse nel comando, suddiviso fra Niccolò Orsini conte di Pitigliano, capitano generale delle milizie, e Bartolomeo d'Alviano, governatore dell'armi, ai quali era affiancato, con il rango di Provveditore Generale, il nobile veneziano Andrea Gritti, come era d'uso nella Repubblica. Bartolomeo d'Alviano, disarcionato e ferito ad un occhio, su ordine del re Luigi non fu ucciso ma tenuto prigioniero per quattro anni (liberato quando Venezia si troverà a combattere assieme alla Francia, nel complicato gioco delle alleanze di quei tempi di rapidi voltafaccia). Il conte di Pitigliano si ritirò verso Venezia con Gritti e le truppe rimastegli, abbandonando tutti i territori occidentali di terraferma. Questa ritirata si fermò, di fatto, soltanto a Mestre. Venezia paventò l'imminente fine della propria Repubblica.
Degni di ricordo, perché influenti sull'esito finale della guerra dopo il disastro di Agnadello, rimangono due momenti di arresto dell'avanzata dei francesi e degli imperiali.
L'onda d'urto di Agnadello aveva dapprima portato il 5 giugno 1509 alla resa di Padova, ma il 17 luglio una contromossa della Serenissima aveva riportato con uno stratagemma la cavalleria e altre forze veneziane dentro la città. La riconquista aveva richiamato la discesa da Trento dell'imperatore Massimiliano per porla sotto assedio, affiancato da contingenti francesi e papali. L'assedio di Padova (difesa da Andrea Gritti, futuro doge dal 1523 al 1538) iniziò il 15 settembre 1509 e fu tolto il 30. Nell'abbandono da parte di Massimiliano pesò l'esaurimento dei fondi per pagare i suoi mercenari.
Anche Treviso, che rappresentava l'ultimo baluardo veneto che separasse Francia e Impero dalla laguna di Venezia, fu investita nel 1511 da un esercito assediante comandato dall'aristocratico francese Jacques de Chabannes de La Palice. Con singolare previdenza, già dal 1509, il Consiglio dei Dieci aveva deciso di potenziare le opere di fortificazione della città, incaricando il celeberrimo architetto militare veronese Fra' Giocondo ( ← it.wikipedia.org ). Furono costruite imponenti mura bastionate e fu deviata parte del fiume Botteniga, in modo che, sbarrato adeguatamente dall'interno in caso di assedio, le sue acque inondassero tutti i terreni circostanti le mura per largo tratto, rendendo malagevole e più facilmente rintuzzabile qualsiasi avvicinamento di armati. La resistenza trevigiana fu tenace per tutta l'estate del 1511 e non fu travolta neppure dal violento e decisivo attacco sferrato tra il 7 e il 15 ottobre di quell'anno. Il sopraggiungere della stagione fredda e le discordie sorte fra i comandi francesi e quelli imperiali portarono alla smobilitazione degli assedianti.
I Libri
L’Europa e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello, a cura di Giuseppe Gullino, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2011 | Atti del convegno, nel V centenario della battaglia di Agnadello, promosso nel 2009 dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti con il contributo della Regione del Veneto | Leggi pdf | ivsla.it/store | istitutoveneto.it
- Giuseppe Galasso, Il quadro internazionale, p. 3
- Giuseppe Gullino, La classe politica veneziana, ambizioni e limiti, p. 19
- Giovanni Zalin, Il quadro economico dello Stato veneziano tra Quattrocento e Cinquecento, p. 35
- Angiolo Lenci, Agnadello: la battaglia, p. 75
- Gian Maria Varanini, La terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello, p. 115
- Maria Pia Pedani, Venezia e l’Impero ottomano: la tentazione dell’impium foedus, p. 163
- Antonio Menniti Ippolito, Il papato, p. 177
- Antonio Conzato, Usurpazione o riorganizzazione? Il Consiglio dei Dieci e la gestione della politica estera veneziana negli anni di Agnadello, p. 191
- Wolfang Mährle, «Deus iustus iudex». La battaglia di Agnadello e l’opinione pubblica nei paesi tedeschi, p. 207
- Gino Benzoni, Parole per dirlo (e figure per tacerlo), p. 229
- Manlio Pastore Stocchi, Riflessi letterari della battaglia di Agnadello, p. 337
La battaglia di Agnadello e il Trevigiano, a cura di Danilo Gasparini, Michael Knapton, Quaderni di Villa Emo 1, Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR), 2011 | edizioni.cierrenet.it | È la pubblicazione degli Atti del Convegno di studi a Villa Emo Fanzolo del 13.6.2011
- Michael Knapton, Agnadello e il Trevigiano, p. 11
- Gianpier Nicoletti, La Dopo Agnadello: danni di guerra, tensioni sociali e trasformazioni urbanistiche a Treviso e nella Marca Trevigiana, p. 29
- Lucio De Bortoli, Cronache e istorie di fedeltà: pagine e immagini del dopo Agnadello nel trevigiano, p. 65
- Lorenzo Morao, I fratelli Emo nella guerra di Cambrai, p. 77
- Franco Rossi, Venti di guerra nei dispacci di Andrea Gritti, Provveditore generale in campo, p. 87
- Andrea Bona, Feltre dopo Agnadello: dal "mito" dell'incendio alla realtà di una guerra di confine, p. 97
- Danilo Gasparini, La fuga dalla città di Treviso, p. 113
Per saperne di più
- [2020] Ettore Beggiato, La Lega di Cambrai e la Serenissima, Prefazione di Lorenzo Boca, Editrice Veneta, Vicenza, 2020 | Reperibilità: editriceveneta.it/Pubblicazioni-Ettore-Beggiato
- [2020] Federico Moro, La Serenissima contro il mondo. Venezia e la Lega di Cambrai (1499-1509), Led edizioni, Gorizia, 2020, Supplem. a Il Gazzettino
- [2015] Lara Pavanetto, La guerra di Cambrai, Venezia accerchiata, e i cittadini “traditori” di Noale | larapavanetto.blogspot.com
- [2014] Raffaele Ruggero, La battaglia di Agnadello, «Enciclopedia machiavelliana (2014) | treccani.it/enciclopedia
- [2013] Nicola Formaio, La Repubblica di Venezia tra la discesa di Carlo VIII e il dramma di Agnadello. I comandanti militari marciani nelle guerre d’Italia, Tesi di laurea, UniVe, 2012/2013, Relatore prof. Sergio Zamperetti | dspace.unive.it
- [2011] Nicolò Dal Grande, Agnadello o "la rotta della Ghiaradadda", 2/2011, «it.cultura.storia.militare online» | icsm.it/articoli
- [1917] G. Dalla Santa, Commerci, vita privata e notizie politiche dei giorni della lega di Cambrai (da lettere del mercante veneziano Martino Merlini), Atti del reale Istituto Veneto di Scienze arti, A. a. 1916-1917, Tomo LXXVI, Parte seconda, pp. 1547-1605 | Leggi pdf | atena.beic.it/view | gutenberg.beic.it/view
- [1866] G. Occioni-Bonaffons, Intorno alle cagioni della Lega di Cambrai. Studio documentato, «Archivio Storico Italiano», Serie terza, Vol. 4, No. 1 (43) (1866), pp. 93-131 | https://www.jstor.org/stable/44453151?seq=1#metadata_info_tab_contents | https://www.jstor.org/stable/pdf/44453151.pdf?refreqid=excelsior%3A97212d1b4b1612f9a1e727211ff178f3
- [1551] Petri Bembi Cardinalis Historiae Venetae Libri XII, Apvd Aldi Filios, Venetiis, MDLI (1551)
- Digitalizzato da Google - Biblioteca Nazionale austriaca: books.google.it/ltdlAAAAcAAJ | Leggi pdf
- Digitalizzato da Google - Biblioteca Nazionale della Repubblica Ceca: books.google.it/id=ps1fAAAAcAAJ
- Digitalizzato da Google - Biblioteca Casanatense: books.google.it/s2jjgu5issQC&pg=PP7
- [XVI sec.] Lettere storiche di Luigi da Porto, Vicentino, dall'anno 1509 al 1528, ridotte a castigata lezione e corredate di note per cura di Bartolommeo Bressan, Felice Le Monnier, Firenze, 1857 | Digitalizzato da varie Università e Biblioteche:
- Google - National Library of Naples: books.google.com/PS_ogh3bS-gC | Internet Archive | Leggi pdf
- Google - Oxford University: books.google.com/G_oNAAAAQAAJ | Internet Archive | Leggi pdf
- Google - Oxford University: books.google.it/D4kHAAAAQAAJ
- Google - Oxford University: books.google.it/DJYBAAAAQAAJ
- Google - Università Sapienza di Roma: books.google.it/JBZ23MM7Z4wC
- Google - Università di Losanna: books.google.it/ZrQPAAAAQAAJ
- [1496-1533] Marino Sanudo, I Diarii | Sanudo si occupò della stesura dei Diarii (58 volumi di complessive 40.000 carte manoscritte) dal 1496 al 1533. La rigorosa e continuativa registrazione dei fatti giorno per giorno fu inizialmente pensata in vista della successiva composizione di una grande storia di Venezia, in seguito, tuttavia, mai realizzata
I link ai 58 Volumi, reperibili in GoogleBooks, Internet Archive o HathiTrust, sono elencati dalla biblioteca dell'Università della Pennsylvania alla pagina: The Online Books Page | onlinebooks.library.upenn.edu
Di seguito si danno i collegamenti ai volumi direttamente attinenti alla guerra della Lega di Cambrai contro Venezia:
- [1882] Marino Sanudo, I Diarii, Volume 7 (1 marzo 1507 - 28 febbraio 1508), dall'autografo Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII, Volume 7, per cura di Rinaldo Fulin, A spese degli Editori (Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet), Tipografia del Commercio di Marco Visentin, Venezia, 1882 | books.google.com/eC3O7wbSPrwC | archive.org | Leggi pdf | Forni Editore, Bologna (Ristampa fotomeccanica)
- [1882] Marino Sanudo, I Diarii, Volume 8 (1 marzo - 31 luglio 1509), dall'autografo Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII, Volume 8, per cura di Rinaldo Fulin, A spese degli Editori (Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet), Tipografia del Commercio di Marco Visentin, Venezia, 1882 | books.google.com/7TxBZ5nQHAIC | Internet Archive | Leggi pdf
- [1882] Marino Sanudo, I Diarii, Volume 9 (1 agosto 1509 - 28 febbraio 1510), dall'autografo Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII, Volume 9, per cura di Rinaldo Fulin, A spese degli Editori (Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet), Tipografia del Commercio di Marco Visentin, Venezia, 1882 | books.google.comx1OX5b09z-0C | Internet Archive | Leggi pdf
- [1882] Marino Sanudo, I Diarii, Volume 7 (1 marzo 1507 - 28 febbraio 1508), dall'autografo Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII, Volume 7, per cura di Rinaldo Fulin, A spese degli Editori (Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò Barozzi, Guglielmo Berchet), Tipografia del Commercio di Marco Visentin, Venezia, 1882 | books.google.com/eC3O7wbSPrwC | archive.org | Leggi pdf | Forni Editore, Bologna (Ristampa fotomeccanica)
- [1561] Francesco Guicciardini, Storia d'Italia, Letteratura Italiana Einaudi (Edizione di riferimento: a cura di Silvana Seidel Menchi, Einaudi, Torino, 1971) | Internet Archive | Leggi pdf
L'opera storiografica del fiorentino Francesco Guicciardini, uomo politico al servizio dei papi medicei Leone X e Clemente VII, è composta di venti libri e narra gli avvenimenti accaduti tra il 1492 (anno della morte di Lorenzo il Magnifico) e il 1534 (anno della morte di Papa Clemente VII). Fu scritta tra il 1537 e il 1540 e pubblicata per la prima volta nel 1561 a Firenze.
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2857

[2010] Alessandro Barbero, Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Laterza, Roma-Bari, 2010 | Leggi l'estratto |

Alessandro Barbero, Creatività distruttrice 2. Lepanto 1571 | https://youtu.be/SjG1j3ndrFU
- [2017] Stefan Hanß, Eine Zeit-Geschichte der Seeschlacht von Lepanto, «Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit», 21, pp. 171-212 | publishup.uni-potsdam.de
- [2012] Elizabeth R. Wright, Enredos historiográficos: Lope ante Lepanto, «Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura», XVIII (2012), pp. 146-174 | core.ac.uk/download
- [2005] Arrigo Petacco, La croce e la mezzaluna. Lepanto 7 ottobre 1571: quando la Cristianità respinse l'Islam, Mondadori, Milano, 2005 | Reperibilità: ...
Andiamo in archivio
- [1899] Pompeo Molmenti, Sebastiano Veniero e la battaglia di Lepanto, Studio di Pompeo Molmenti, G. Barbèra Editore, Firenze, 1899 | ubsm.bg.ac.rs | Leggi pdf (resolve.ubsm.bg.ac.rs) | Leggi pdf (resolve.ubsm.bg.ac.rs (definizione più alta)
- [1899] Giuseppe Bianchini, Recensione a Pompeo Molmenti, Sebastiano Veniero e la battaglia di Lepanto, Studio di Pompeo Molmenti, «Archivio Storico Italiano», Serie V, Vol. 23, No. 214 (1899), pp. 418-429, Leo S. Olschki, Firenze | jstor.org/44457535
- [1870] Lettere di Onorato Caetani capitan generale delle fanterie pontificie nella battaglia di Lepanto pubblicate da G.B. Carinci, coi tipi del Salviucci, Roma, 1870 | archive.org/SMJvTZL0v0gC | Leggi pdf | books.google.it/SMJvTZL0v0gC
- [1863] Girolamo Diedo, La battaglia di Lepanto descritta da Gerolamo Diedo e La dispersione dell'Invincibile Armata di Filippo II, G. Daelli e Comp. Editori, Milano, 1863 | books.google.it/n6XUJtyLKVwC | books.google.it/AIJt0FNfxT8C | books.google.it/8acPnQEACAAJ
- [1862] Alberto Guglielmotti, Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto, Felice Le Monnier, Firenze, 1862 | archive.org | Leggi pdf
- [1852] Relazione della battaglia di Lepanto dell'anno 1571 di Alvise Soranzo, patrizio veneto, Dalla Tipografia di Giovanni Cecchini, Venezia, 1852 | babel.hathitrust.org
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 3100
Walter Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento, Viella Ed., Roma 2014 | Reperibilità: ...
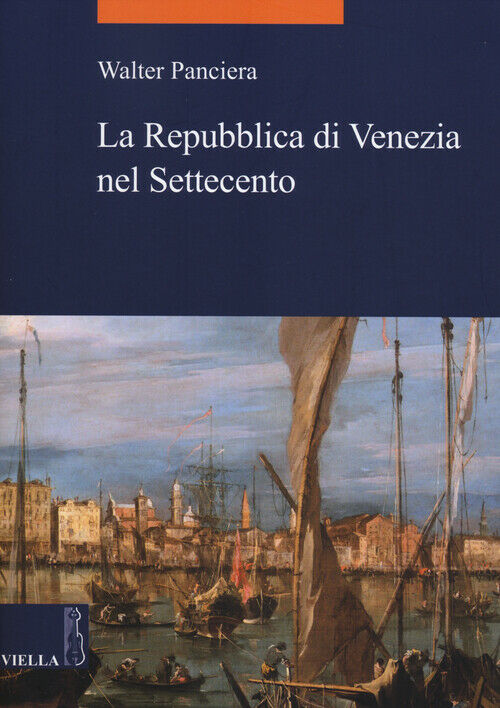 Nel libro si ripercorre la storia della Repubblica aristocratica di Venezia nel XVIII secolo per contrastare le visioni stereotipate dell'ultimo secolo di vita di un antico stato, del suo territorio e di una società complessa, nei quali non mancarono contraddizioni, nuovi fermenti e antiche debolezze. La Serenissima, infatti, non divenne mai una nazione moderna, nel senso che oggi si dà a questa espressione. La metropoli di Venezia rimase fino all'ultimo e in modo consapevole non una capitale, bensì la Dominante. Particolarismo e policentrismo sono la chiave per capire i limiti e forse l'eredità profonda del suo dominio, da Corfù fino all'Adda. La debolezza della Repubblica di fronte ai grandi stati europei si rivelò nel Settecento tanto più evidente in quanto frutto dell'evoluzione di una città-stato ferma nei suoi caratteri fondamentali a due secoli prima, quando aveva raggiunto il vertice della sua potenza. [dissgea.unipd.it] Nel libro si ripercorre la storia della Repubblica aristocratica di Venezia nel XVIII secolo per contrastare le visioni stereotipate dell'ultimo secolo di vita di un antico stato, del suo territorio e di una società complessa, nei quali non mancarono contraddizioni, nuovi fermenti e antiche debolezze. La Serenissima, infatti, non divenne mai una nazione moderna, nel senso che oggi si dà a questa espressione. La metropoli di Venezia rimase fino all'ultimo e in modo consapevole non una capitale, bensì la Dominante. Particolarismo e policentrismo sono la chiave per capire i limiti e forse l'eredità profonda del suo dominio, da Corfù fino all'Adda. La debolezza della Repubblica di fronte ai grandi stati europei si rivelò nel Settecento tanto più evidente in quanto frutto dell'evoluzione di una città-stato ferma nei suoi caratteri fondamentali a due secoli prima, quando aveva raggiunto il vertice della sua potenza. [dissgea.unipd.it]
|
Walter Panciera, Napoleone nel Veneto. Venezia e il generale Bonaparte (1796-1797), Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR), 2008
 Tra aprile e giugno del 2003 si sono svolte a Venezia le prime tre udienze di uno strano processo postumo. L’accusato, Napoleone Bonaparte, morto nel 1821, deve rispondere del “tracollo economico, sociale e, infine, politico”, provocato ai danni dell’antica Serenissima repubblica nel biennio 1796-1797. L’autore è stato invitato a fornire la sua testimonianza, a discarico dell’allora generale di corpo d’armata, secondo quanto previsto dall’odierna procedura penale. Questo libro sviluppa le riflessioni nate in questo contesto. Alla ricostruzione dei fatti, seguono le puntuali risposte ai quesiti che lo storico si è posto per prepararsi all’interrogatorio. Con l’avvertenza che compito della storia è “non giudicare, bensì comprendere”. [edizioni.cierrenet.it] Tra aprile e giugno del 2003 si sono svolte a Venezia le prime tre udienze di uno strano processo postumo. L’accusato, Napoleone Bonaparte, morto nel 1821, deve rispondere del “tracollo economico, sociale e, infine, politico”, provocato ai danni dell’antica Serenissima repubblica nel biennio 1796-1797. L’autore è stato invitato a fornire la sua testimonianza, a discarico dell’allora generale di corpo d’armata, secondo quanto previsto dall’odierna procedura penale. Questo libro sviluppa le riflessioni nate in questo contesto. Alla ricostruzione dei fatti, seguono le puntuali risposte ai quesiti che lo storico si è posto per prepararsi all’interrogatorio. Con l’avvertenza che compito della storia è “non giudicare, bensì comprendere”. [edizioni.cierrenet.it] |
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 3235
Giuseppe Gatteri, Francesco Zanotto, Storia veneta espressa in centocinquanta tavole inventate e disegnate da Giuseppe Gatteri sulla scorta delle cronache e delle storie e secondo i vari costumi del tempo, incise da Antonio Viviani e dai migliori artisti veneziani ed illustrate da Francesco Zanotto, Giuseppe Grimaldo, Venezia, 1863.
Nel sito storiaveneta.it e nel sito veja.it è disponibile una versione dell'opera di Zanotto-Gatteri, rielaborata e impaginata per il web da Giorgio Marenghi, corredata dalle schede storiche di Laura Poloni
→ VEDI: veja.it/storia-veneta
Le tavole iniziali
- Nel 452 d.C. Attila e il suo popolo invasero il nord dell’Italia. Da Aquileia, da Padova, dai centri minori, le genti venete dovettero cercare scampo nelle isolette della laguna, che da quel momento divenne un centro abitativo, politico e alla fine anche militare per la difesa del litorale adriatico dalle ricorrenti invasioni.
- L’irruzione dei Longobardi sconvolge il territorio padano mettendo in crisi il governo bizantino che è costretto sulla difensiva. Le popolazioni non più difese cercano scampo ancora una volta nei centri abitati della laguna, ormai divenuta un territorio franco e autogestito. Nell’esodo gli abitanti di Altino si portano appresso parte dei loro beni e le reliquie dei Santi …
- Dopo gli Altinati è la volta degli abitanti di Aquileia a dover scappare davanti all’avanzata dell’esercito longobardo. Il vescovo Paolo guida il suo popolo verso una nuova patria, nella laguna amica, unico rifugio sicuro al riparo dalle incursioni di nemici sanguinari e barbari.

→ CONTINUA A LEGGERE: veja.it/storia-veneta
L'opera Storia veneta di Francesco Zanotto, riedita da Dario De Bastiani editore (2017)
Di grande interesse oltre che di raffinata qualità grafica è la riproposizione del testo ottocentesco, Zanotto Francesco, Storia veneta in centocinquanta tavole inventate e disegnate da Giuseppe Gatteri, 2 volumi, De Bastiani editore, Vittori Veneto, 2017 | Reperibilità: debastiani.it/catalogo
Giuseppe Lorenzo Gatteri
- Patrizia Fasolato, Giuseppe Lorenzo Gatteri, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 52 (1999) | treccani.it/enciclopedia
- Giuseppe Lorenzo Gatteri | biblioteche.comune.trieste.it
- Vania Gransinigh, Gatteri Giuseppe 1799-1878 (Si tratta del padre di Giuseppe Lorenzo Gatteri) | dizionariobiograficodeifriulani.it
- Disegni del pittore Giuseppe Lorenzo Gatteri (1829-1884) | Civico Museo Revoltella di Trieste | triestecultura.it
- Giuseppe Gatteri (1829-1884), illustratore della monumentale Storia Veneta ristampata dal Gazzettino, 18.2.2019 | ilgazzettino.it
- Gallerie | Pittori triestini: Giuseppe Lorenzo Gatteri | atrieste.eu
 Fonte dell'immagine: triestecultura.it
Fonte dell'immagine: triestecultura.itFrancesco Zanotto
- Francesco Zanotto, Storia della pittura veneziana, Tipografia di Giuseppe Antonelli, Venezia, 1837 | books.google.it/feDNuRPBd_wC | Leggi pdf
- La regina Catterina Cornaro in atto di cedere la corona di Cipro alla Republica Veneziana. Dipinto di Paolo e Carlo Caliari, illustrato da Francesco Zanotto, coi tipi di G. Antonelli , Venezia, 1840 | books.google.it/gyhZAAAAcAAJ | Princeton books.google.it/QhstAAAAYAAJ | Leggi pdf
- Arringa per Francesco Zanotto detta dall'avvocato Leone Fortis nel Consiglio del Tribunal criminale di Venezia il dì 13 marzo 1849, Coi tipi di Gio. Cecchini, Venezia, 1849 | Digitalizzato da Google - Harvard University: books.google.it/wN0uAAAAYAAJ | Leggi pdf | Digitalizzato da Google - Biblioteca nazionale austriaca: books.google.it/tIVkAAAAcAAJ | Leggi pdf
- Il Palazzo ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto, Vol. 1, A spese degli editori, Stabilimento di G. Antonelli, Venezia, 1852 | books.google.it/Mw5BAAAAcAAJ
- Il Palazzo ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto, Vol. 2, Nel privilegiato stabilimento nazionale di Giuseppe Antonelli editore, Venezia, 1858 | books.google.it/HyVdjhOUSSIC | Leggi pdf
- Il Palazzo ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto, vol. 3, Nel privilegiato stabilimento nazionale di Giuseppe Antonelli editore, Venezia, 1858 | books.google.it/7YJXsi1_R9MC | Leggi pdf
- Il Palazzo ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto, vol. 4, Nel privilegiato stabilimento nazionale di Giuseppe Antonelli editore, Venezia, 1861 | archive.org | Leggi pdf
- Francesco Zanotto, Il fiore della scuola pittorica veneziana illustrato con trentasei incisioni in acciaio, Sezione letterario-artistica del Lloyd Adriatico, Trieste, 1860 | books.google.it/BRss9x_Vn80C | Leggi pdf | archive.org | Leggi pdf | archive.org | Leggi pdf
- Francesco Zanotto, Pinacoteca veneta, ossia, Raccolta dei migliori dipinti delle chiese di Venezia, Vol. I, Coi tipi di Giuseppe Grimaldo, Venezia, 1867 | archive.org | Leggi pdf
- Francesco Zanotto, Pinacoteca veneta, ossia, Raccolta dei migliori dipinti delle chiese di Venezia, Vol. II, Coi tipi di Giuseppe Grimaldo, Venezia, 1860 | archive.org | Leggi pdf
- Tavola cronologica della storia veneta nella quale anno per anno sono segnate le guerre, le vittorie, i fatti illustri, la erezione delle fabbriche e dei monumenti, la fondazione delle chiese e de' monasteri, l'insituzione de' magistrati, la promulgazione delle principali leggi, la nascita e la morte degli uomini illustri, la elezione de' dogi, de' vescovi, de' patriarchi, de' primicerii, de' cancellieri grandi, ec. ec. ec., compilata da Francesco Zanotto, Giuseppe Grinaldo Tip. e Calc., Venezia, 1859 | books.google.it/TE63j8QhfmwC | Leggi pdf arielcaliban.org
- Francesco Zanotto, Storia della Repubblica di Venezia, Tomo II, Editore l'Autore, Venezia, 1864 | books.google.it/qPPJn6-vp0QC | Leggi pdf
- I Pozzi e i Piombi antiche prigioni di stato della Repubblica di Venezia, Commentario di Francesco Zanotto, con due tavole dimostranti la opianta e lo spaccato delle prigioni stesse, Gio. Brizeghel Tip. Lit. Lib. Editore, Venezia, 1876 |books.google.it/kZdpAAAAcAAJ | Leggi pdf
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2920
La storia millenaria del Veneto raccontata da Francesco Jori
Un nuovo volume racconta l'epopea di una regione che è caduta e si è rialzata innumerevoli volte, riuscendo sempre a riscattarsi da ogni calamità

L'INTRODUZIONE
Benvenuti nel nostro quarto millennio. Avrebbe potuto far leva su un simile intrigante slogan, un marketing veneto dedicato, ormai diciott’anni or sono, al giro di boa tra Novecento e Duemila.
Sì, perché questa regione conosciuta dall’esterno soprattutto per il glorioso ed esaltante imprinting millenario della Serenissima, in realtà può mettere in campo una storia già lunga tremila anni; oltretutto con alle spalle una preistoria remota.
Potendo inoltre contare, come anello di congiunzione tra le due epoche, su un mito di alto livello, parificato a quello della Roma “caput mundi”: anche qui, in veste di progenitore, un eroe reduce dalla guerra di Troia, Antenore come Enea. O, a voler cercare di attualizzarlo, un profugo fuggito con alcuni compagni da uno dei più sanguinosi conflitti del Medio Oriente: sbarcato su una spiaggia dopo una lunga e perigliosa navigazione attraverso il Mediterraneo su una carretta del mare; trovando una nuova terra da cui ripartire, una nuova cittadinanza da conquistare.
Con una sostanziale differenza, peraltro: se la nascita di Roma è marchiata da un delitto fratricida, la vicenda veneta si propone come un percorso di riuscita integrazione. Imprimendo così al Veneto quel Dna che è rimasto sostanzialmente integro attraverso i secoli anzi i millenni: l’accoglienza, lo scambio, il dialogo, il confronto; in una parola, l’apertura al mondo. Che troverà idealmente in Marco Polo il testimonial più genuino.
Bastano queste poche considerazioni per far capire quanto complesso sia il tentativo di proporre una storia del Veneto che non si limiti alla stra-narrata millenaria stagione della Serenissima Repubblica di Venezia e dello stra-gettonato leone di san Marco; ma cerchi di rivisitarne radici e matrici, nel tentativo (dirà il lettore se e quanto riuscito) di mettere allo scoperto le costanti che garantiscono a questa regione la sua specificità.
Operazione complessa e rischiosa, certo: specie in una turbolenta stagione come quella presente, in cui è venuta maturando una vera e propria “questione veneta” peraltro affrontata più a colpi di slogan che a scavi sul campo; e che ormai da oltre tre decenni oscilla tra rivendicazioni di autogestione e pulsioni di strappi da un’Italia vissuta da molti come nemica.
Suggerendo peraltro una domanda terra-terra, al di là delle posizioni di parte: come mai nessun’altra realtà territoriale ha rivendicato così a lungo e con forza una propria autonomia, senza mai essere finora riuscita a portarne a casa neppure una briciola?
Con tutta la dovuta modestia, questo libro vuole essere un tentativo di fornire una risposta non banale, proprio rivisitando il lungo e intricato cammino che le genti venete hanno percorso: attraverso stagioni di straordinario splendore politico, economico, sociale, culturale; ma anche di miseria, depressione, marginalità, decadenza.
Partendo da una premessa, che è poi un pensiero del grande compositore Gustav Mahler: tradizione è conservare il fuoco, non adorare le ceneri. In altri termini, esplorare il passato non per rimpiangerlo, tanto meno per cercare di riproporlo; ma semplicemente perché lì, e solo lì, c’è la mappa per esplorare il futuro. Operazione tanto più necessaria oggi, in cui una tumultuosa trasformazione sta letteralmente sconvolgendo la realtà in cui viviamo, rischiando di farci perdere le coordinate interiori e di trasformarci in naufraghi del presente: ha ragione da vendere lo scrittore Predgar Matvejevic, potente voce mediterranea a cavallo tra mondi diversi, quando sottolinea che in fondo oggi siamo tutti ex di qualcosa. Ottima ragione dunque per riproporre, in chiave moderna, l’antica e fondamentale trilogia di domande: chi siamo, da dove veniamo, e soprattutto dove stiamo andando?
Sotto questo profilo, non c’è dubbio alcuno che negli ultimi vent’anni, in questo primo scorcio di Duemila, il Veneto – anche il Veneto – sia cambiato molto più che nei precedenti venti secoli; e tutto autorizza a supporre che tra altri vent’anni assomiglierà ben poco a quello di oggi.
Cito al riguardo un’esperienza personale, maturata nella mia attività di giornalista: l’incontro con un emigrato di seconda generazione, nato in Brasile e venuto in viaggio della memoria nel Trevigiano, la terra dei padri, con una qualche suggestione di stabilirvisi a tempo pieno. Proposito quasi subito abbandonato, nella traumatica scoperta che il Nordeste brasiliano dov’era nato e dove viveva rispecchiava in realtà le radici e le tradizioni originarie dei suoi genitori molto più dell’odierno turbolento Nordest italiano.
E’ solo un piccolo periferico segnale, ma comunque indicativo, di quella straordinaria mutazione antropologica che il Veneto attuale sta attraversando, con l’impatto di uno tsunami che fa strame di certezze acquisite, schemi consolidati, stereotipi consunti. Una terra che Emilio Franzina ha efficacemente definito come quella della “transizione dolce” tra generazioni, il luogo della stabilità conclamata, la realtà individuale e collettiva fotografata nello slogan dialettale del “mi non vago a combàtar”, si è traumaticamente trasformata in un mosaico composito di culture, etnìe, valori in cui prevale la logica del conflitto.
Tracciando il lungo percorso di tremila anni dai confini con la preistoria ai giorni nostri, dall’Età del Bronzo a quella della Rete, questo libro si pone in ultima analisi un dichiarato proposito: fornire a chi lo leggerà non risposte ma stimoli. Uno, soprattutto: sollecitare i veneti di oggi e di domani a non rimanere vittime di questa rivoluzione esistenziale, ma a sforzarsi di forgiare gli strumenti per far sì che il conflitto non venga vissuto come scontro ma come confronto, facendo della diversità una risorsa e non un limite.
Ci vorranno tempo, pazienza e fatica: l’equivalente del celebre “sangue, sudore e lacrime” di Winston Churchill, in versione terzo millennio; perché la convivenza con l’altro (e perché no?, anche con se stessi) è una dura scuola in cui si apprende lentamente, per prove ed errori.
Ma è anche la sola strada per non smarrire la rotta e scongiurare un devastante naufragio sugli insidiosi scogli del presente: significa, per gli Ulisse protagonisti dell’odissea del presente, voler bene al Veneto e farne la loro Itaca, alla quale ritornare trasformati e cresciuti, senza rimpianti per ciò che è stato ieri ma con passione per ciò che diventerà domani. Per scoprire magari, come nel suggestivo “Racconto dell’isola sconosciuta” di Josè Saramago, che la caravella concessa dal re all’aspirante navigatore non è il mezzo con cui affrontare la sua ricerca, ma che nel nome stesso della nave c’è già la meta. E che quell’isola non è una remota utopia: la sta già abitando.
***
Alcune doverose istruzioni per l’uso. Partendo da un concetto che ho già chiarito in altri lavori, ma che ritengo opportuno ribadire a maggior ragione in e per questo libro. Faccio outing, come si direbbe oggi: non sono uno scrittore, tanto meno uno storico. Sono un giornalista, e come tale sono consapevole di essere esposto all’insidioso rischio a suo tempo segnalato da Gilbert Keith Chesterton: “Il giornalismo consiste principalmente nel dire ‘Lord Jones è morto’ a persone che non hanno mai saputo che Lord Jones fosse vivo”. Tradotto in soldoni: non dare nulla per scontato.
Ciò premesso, considero questo testo come un contributo a un genere giornalistico purtroppo in via di estinzione, l’inchiesta. E quindi l’ho affrontato utilizzando gli strumenti che ho appreso in mezzo secolo di attività, grazie a molte disordinate ma preziose letture, e a pochi ma ottimi veri maestri della professione. Sforzandomi di mettere assieme dati e testimonianze, aspetti noti e curiosità minori; di far parlare gli altri anziché l’io narratore; soprattutto di raccordare la narrazione al contesto per far capire la trama degli eventi e il loro significato: terreno su cui a mio personale avviso l’informazione odierna è colpevolmente carente.
Ho cercato di non ricavarne un trattato di storia, perché ne esistono già molti alcuni dei quali (alcuni…) pure autorevoli; e ancor più perché non ne ho assolutamente la competenza. Ci sono dunque diversi passaggi su cui mi sono limitato ad offrire solamente gli spunti essenziali per fornire la sequenza degli eventi: così ad esempio sulla presenza di Roma nel “Venetorum angulus”, sulle tappe principali della Serenissima, sulle due guerre mondiali del Novecento.
Ho cercato di limitare il più possibile il ricorso alle date, ai nomi, ai dettagli, per concentrarmi sulle dinamiche dei processi in atto attraverso i secoli; sulle connessioni tra i diversi ambiti politico, economico, sociale, culturale; sulle costanti che riaffiorano nello scorrere del tempo e nel mutare degli uomini.
Infine, pur consapevole di quanto scivoloso sia sempre affrontare il tema del presente, ho voluto arrivare fino ai giorni nostri per proporre una descrizione sia pure sommaria dei processi in atto; e a quel punto, superando ogni limite di prudenza, mi sono sia pur rapidamente addentrato in un tentativo di sguardo sul futuro. Mi prendo dunque l’intera responsabilità delle opinioni espresse, assolutamente personali; e faccio ammenda per i sicuramente copiosi peccati in pensieri, parole, opere e omissioni che costellano il testo. Consapevole del fondamentale limite di essere un giornalista che scrive un libro, e soprattutto un libro di storia, non mi resta che invocare per me ciò che espresse Alcide De Gasperi aprendo il suo intervento alla conferenza di pace di Parigi dopo la seconda guerra mondiale: “Prendendo la parola oggi in questa sala, sento che tutto mi è contro tranne la vostra personale cortesia”.
INDICE
- INTRODUZIONE DI FRANCESCO JORI
LA STORIA DEL VENETO
- “PRIMA GLI EUGANEI”. Imprenditori da export fin dalle origini
- “CIVIS PRAECIPUA, URBICULA SUAVIS”. Patavium e le altre: le città venete in epoca romana
- “OGNI CURA NELL’APRIRE STRADE”. La Roma (di ieri…) maestra in infrastrutture
- “AD SOLUM USQUE DESTRUCTA EST”. I secoli bui e devastanti delle grandi invasioni barbariche
- “ORA, LABORA E FAI AFFARI”. La ricostruzione e l’emergere di una borghesia cittadina
- “SI È ORNATA DEL FIORE DI TUTTE LE SCIENZE”. L’università motore del risveglio culturale e della libertà del conoscere
- “QUANDO GIUNSERO ALLA GRAN CITTÀ”. Marco Polo prototipo di generazioni di imprenditori rampanti
- “EL ZOVENE PROCURATOR NOSTRO…”. La svolta della Serenissima dal mare alla terraferma
- “LA CITTÀ PIÙ RICCA E LUSSUOSA DEL MONDO”. Il secolo lungo della Serenissima, dalla guerra al benessere
- “UN MASTRO ANCOR GIOVANE E OSCURO”. Il segno di Palladio e la straordinaria stagione culturale veneziana
- SETTE CAPOLUOGHI. Piccola passeggiata nella meraviglia (Le tavole di Giuseppe Gatteri)
- “UN PRETE GRASSO CHE MANGIA CAPPONI”. La chiesa e la stagione della controriforma nel Veneto bianco
- “LE GRAN TESTE MANCANDO SE NE VA”. Il lento declino della Serenissima e la sua morte al buio
- “E POI SUCCESSE UN QUARANTOTTO”. Un travagliato Ottocento e un Veneto passato per tre stati
- “UNA VITA SECOLARE DI MISERIA”. Il Veneto italiano in preda alla fame e devastato dalla pellagra
- “COGLI OCHI PIANGENTI IN GINOCHIO”. Il dramma dell’emigrazione di massa che svuota una regione
- “O PRETE O FRATE O FORA COE VACHE”. La chiesa mater et magistra e la profonda religiosità popolare
- “CON NOI VINCITORI IL PAESE RISORGE”. I capitani d’industria precursori del futuro Veneto dei miracoli
- “CIÒ CHE ABBIAMO AMATO SARÀ DISTRUTTO”. Due guerre mondiali in trent’anni e un Veneto ridotto in macerie
- “LA BIANCA SACRESTIA D’ITALIA”. Il cammino parallelo di una politica monocolore e un’economia rampante
- “IO BEPI, TU ALÌ: NOI E LORO”. La geografia umana del nuovo Veneto tra immigrati e anziani
CONGEDO AFFIDATO A UNA FIABA
Pubblicato su "Il Mattino di Padova" | mattinopadova.gelocal.it
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2861
Anton Friederich Büsching (Stadthagen, 1724 - Berlino, 1793)
 Anton Friederich Büsching, teologo, filosofo e geografo, scrisse la Neue Erdbeschreibung (Nuova descrizione della Terra), un’opera di grande mole a carattere statistico-geografico divisa in undici libri, che segna un progresso sulle cosmografie precedenti: una sorta di enciclopedia geografica “Treccani” del diciottesimo secolo. È certo d'interesse per la nostra informazione storica riscontrare la trattazione dei nostri territori nel secondo e terzo tomo della Italia geografico-storico-politica, pubblicata in traduzione italiana a Venezia nel 1780.
Anton Friederich Büsching, teologo, filosofo e geografo, scrisse la Neue Erdbeschreibung (Nuova descrizione della Terra), un’opera di grande mole a carattere statistico-geografico divisa in undici libri, che segna un progresso sulle cosmografie precedenti: una sorta di enciclopedia geografica “Treccani” del diciottesimo secolo. È certo d'interesse per la nostra informazione storica riscontrare la trattazione dei nostri territori nel secondo e terzo tomo della Italia geografico-storico-politica, pubblicata in traduzione italiana a Venezia nel 1780.
- Anton Friedrich Büsching | de.wikipedia.org | en.wikipedia.org
- Anton Friedrich Büsching | blogs.urz.uni-halle.de
- Anton Friedrich Büsching, La Italia geografico-storico-politica: con un appendice di considerabili aggiunte, con due indici nel fine, l'uno geografico, e l'altro delle cose notabili, e delle persone illustri in essa nominate, oltre la tavola degli articoli contenuti in quest'appendice, Tomo II che comprende l'introduzione alla Repubblica di Venezia, il Cremasco, il Bergamasco, il Bresciano, il Salodiano, il Veronese, il Colognese, il Vicentino, il Padovano, il Polesine, il territorio d'Adria, il Dogado, il Trevisano, Presso Antonio Zatta, Venezia, 1780 | books.google.it/6P4GAAAAcAAJ | Leggi ebook
- Anton Friedrich Büsching, La Italia geografico-storico-politica, di molto accresciuta, corretta e ornata di rami, con un appendice di considerabili aggiunte, con due indici nel fine, l'uno geografico, e l'altro delle cose notabili, e delle persone illustri in essa nominate, oltre la tavola degli articoli contenuti in quest'appendice, Tomo III che comprende la continuazione della Marca Trevigiana, il Bassanese, il Feltrino, il Bellunese, il Friuli, l'Istria, la Dalmazia, ed il Levante, Presso Antonio Zatta, Venezia, 1780 | books.google.it/qv4GAAAAcAAJ | Leggi ebook
- Dettagli
- Scritto da Adriano Miolli
- Categoria: Repubblica di Venezia
- Visite: 2426

Cristina Vendrame, Luciano Mingotto, Maria Teresa Tolotto
Oderzo Veneziana. Evoluzione urbana, città dipinta e dimore storiche
Becco Giallo Editore, 2017
Il libro propone un sintetico excursus dell’evoluzione urbana ed edilizia di Oderzo, alla luce dei ritrovamenti archeologici e dei restauri architettonici degli ultimi venti anni che hanno arricchito – e modificato – la conoscenza della storia della città. Sono inserite alcune schede riguardanti i più importanti manufatti edilizi opitergini le cui decorazioni pittoriche – di facciata e negli interni – non sono ancora state studiate in modo esaustivo e scientifico. Il taglio della pubblicazione è preciso: uno sguardo sulla “venezianità” che ha connotato l’aspetto e la forma, non solo della città e dei suoi edifici, ma anche del territorio.
In tal senso Oderzo è urbs picta come Treviso, Pordenone, Portogruaro e molti altri centri del Nordest, presentando tra XVI e XVIII secolo una splendida cortina di facciate dipinte nel corso Umberto I. Ma non vanno dimenticati gli affreschi entro i palazzi e nelle ville extra urbane come Ca’ Spineda e Ca’ Giustiniani a Busco di Ponte di Piave. Altri preziosi manufatti con facciate dipinte sono presenti nel territorio ma la ricerca si è dovuta limitare a Oderzo per la gran mole documentaria e la complessità dei temi proposti. Il volume si apre con una veloce sintesi dello sviluppo urbano di Oderzo dall’età bassomedievale ai nostri giorni, con richiami alle preesistenze di epoca romana che hanno condizionato parte della rete viaria. Segue un capitolo sulle facciate dipinte su cui sono oggi ancora riconoscibili una serie di fasi decorative e pittoriche dall’età tardogotica al XIX secolo.
Il volume presenta infine alcuni palazzi e ville con affreschi di notevole fattura che non sono noti al grande pubblico, ed è arricchito da due schede a cura di Luca Majoli, storico dell’arte, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.[trevisotoday.it]
- Presentato a palazzo Ferro-Fini il volume "Oderzo Veneziana" | ansa.it
- Affreschi e palazzi. La città veneziana diventa un volume | tribunatreviso.gelocal.it
Repubblica veneziana
- Oderzo Veneziana. Evoluzione urbana, città dipinta e dimore storiche
- Anton Friedrich Büsching, La Italia geografico-storico-politica
- La Repubblica di Venezia nel Settecento
- La storia del Veneto dalle origini ai giorni nostri
- Storia del Veneto e di Venezia illustrata con le tavole di Giuseppe Gatteri
- Lepanto. La battaglia dei tre imperi
- L'Europa e la Serenissima. La svolta del 1509
- Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento
- Degl'Istorici delle cose veneziane
- Lavorare l’acqua e la terra. L’incolto produttivo nella gronda lagunare di Venezia alla fine del Medioevo
- Accadde oggi | 31 ottobre 1517: Lutero pubblica le sue 95 Tesi
- Tra spezie e spie – Filippo Pigafetta nel Mediterraneo del Cinquecento
- Temi di storia veneziana
- Donne veneziane pioniere del diritto allo studio e al lavoro
- Un regno tra la Terra e il Cielo ... ascesa e caduta del Patriarcato di Aquileia
© 2026 am+